
Venti di recessione tirano un po’ ovunque. La guerra rivendica senza sosta il suo prezzo di sangue e devastazione. Non ci sono più spazi sicuri dove accumulare tranquillamente capitali o dove condurre serenamente la propria esistenza. Il prezzo più alto di questa situazione lo pagano donne e uomini poveri, quelli che lavorano o che migrano, tutti coloro che vogliono affermare la propria libertà dal dominio e dalla sopraffazione. Il disordine è grande, ma la situazione non è propriamente eccellente. Sarebbe tuttavia fuorviante pensare che in questo apparente vuoto politico capitalisti e sfruttatori di vario tipo e misura possano muoversi liberi da ogni impedimento. Oggi un capitale affamato di profitti si aggira in un ambiente ostile, che offre poche garanzie e alta volatilità. Questa ostilità non ha tanto il volto di incauti banchieri centrali, ma piuttosto quello di uomini e donne, precarie, operai e migranti, che rifiutano di accettare la cappa di stabilizzazione che si vorrebbe calare sulle loro teste. Ed è questo il volto che fa più paura a chi vorrebbe realizzare il governo di una società in macerie e chiamarlo stabilità.
Quando parliamo di stabilità ci riferiamo al tentativo in atto da parte dei sistemi politici nazionali e internazionali di mettere al sicuro produzione e riproduzione sociale, scosse prima dalla pandemia e poi da una guerra dagli effetti globali. Non siamo di fronte a una rinazionalizzazione della politica, ma a incerti tentativi pubblici di salvaguardare il tasso di profitto dei capitali da un disordine transnazionale che assume le forme, tra le altre, di una guerra dai tratti ormai apertamente mondiali, della crisi climatica e della recessione. Proprio perché poggia su bilanci malmessi, messi sotto assedio da debiti pubblici crescenti e tassi di interesse altissimi, questa stabilizzazione politica del capitale deve essere considerata velleitaria. Velleitaria perché costretta a inseguire con strumenti nazionali un controllo di capitali transnazionali che cercano sì il sostegno pubblico, ma non sono disposti a lavorare per l’interesse e la sicurezza nazionali. La facilità con cui le sanzioni alla Russia vengono aggirate ne è la più chiara dimostrazione. Ma questo tentativo di stabilizzazione è velleitario e, infine, impossibile, perché costretto poi a ricorrere a un violento comando sul sociale per governare come emergenza ciò che emergenza non è. Perché non c’è emergenza laddove l’opposizione di donne, migranti, operai e precari non si adegua a una stabilità scritta con un incrostato linguaggio neoliberale. C’è, semmai, il normale rifiuto che insorge contro un ordine tanto soffocante quanto impossibile.
Stabilizzazione è allora il nome di un progetto politico di cui le destre al governo sono solo il punto di massima tensione ideologica. Dietro a quel progetto c’è la rincorsa affannosa di un neoliberalismo che dalla crisi del 2008 in avanti non ha mai smesso di cambiare pelle, pur rimanendo fedele ai dogmi del mercato e della moneta e dell’uso funzionale del comando statale. Le destre al potere consentono di esercitare un comando autoritario su lavoratori, donne e migranti, ovvero su chi negli ultimi anni ha sfidato l’ordine violento della coazione al lavoro, del patriarcato e del razzismo. Questa tensione autoritaria, patriarcale e razzista si rivela oggi necessaria a puntellare un ordine neoliberale che si contrappone violentemente a ogni richiesta di salario e di reddito, alle grandi dimissioni e al labor shortage. Non si tratta di gridare al fascismo, ma di registrare che, dopo la breve sospensione pandemica, le mediazioni istituzionali, quando ci sono, sono comunque orientate a ristabilire un pieno comando sul lavoro e a riaffermare le più tradizionali gerarchie sessuali e razziste.
Il covid ha fatto crescere sui luoghi di lavoro il seme dell’arroganza, come non ha mancato di notare qualche imprenditore senza peli sulla lingua. Un’arroganza che non è rimasta un fatto privato, ma si è fatta insubordinazione negli scioperi inglesi, nelle lotte contro la riforma delle pensioni in Francia, negli scioperi statunitensi nel ciclo dell’auto e perfino in quelli degli sceneggiatori di Hollywood. Per rispondere a tutte queste insorgenze, la stabilizzazione cerca almeno di estirpare questa malapianta dai luoghi di lavoro. Ecco allora che ne derivano ulteriori tagli drastici al welfare, mentre si discute, senza giungere a un quadro stabile, di quanto austero debba essere il nuovo patto europeo di stabilità. Che si tratti di cancellare il reddito di cittadinanza come ha fatto Meloni, di escludere donne e uomini migranti dai benefici del welfare tedesco come annuncia il ministro delle finanze Lindner, o di privatizzare quel poco che è rimasto di pubblico in Argentina, come promette il candidato e favorito alle presidenziali, l’ultraliberista Milei, l’obiettivo è sempre quello di generare forza lavoro disponibile e a basso costo. D’altronde, non c’è modo migliore che contenere i salari per riportare a più miti consigli chi lavora, agitando poi lo spettro della recessione per giustificarne i sacrifici. Lo sa bene il governo conservatore greco, che sta mettendo a punto una legge per estendere l’orario di lavoro a 13 ore, nonostante le migliaia di uomini e donne scese in piazza ad Atene il 21 settembre. D’altra parte, la repressione sfoderata del moderato Macron contro il movimento che contestava la riforma delle pensioni ha fatto scuola anche a destra e il governo greco non intende fare marcia indietro, imponendo ulteriore miseria a una popolazione già stremata dalle cure della Troika. Nel sogno stabilizzatore, d’altronde, il ‘vecchio’ neoliberalismo e la ‘nuova destra’ si trovano così in perfetta armonia.
La stabilizzazione potrebbe però rivelarsi un progetto impossibile, perché destinata a scontrarsi con una molteplicità di rifiuti più o meno organizzati in grado di mettere in crisi ogni pretesa di mediazione istituzionale o ideologica. Alla fine, nemmeno la guerra in Ucraina è riuscita a imporre uno schieramento e una divisione funzionali all’ordine bellico di oggi e alla ricostruzione di domani. Il nuovo conflitto nei territori palestinesi e in Israele non esprime, d’altra parte, l’instaurazione di un qualche regime di guerra, che, ad ogni evidenza, non regge l’urto del disordine transnazionale. Esso si inquadra, piuttosto, nel solco della stabilità impossibile, entro cui si inscrive la lunga storia di segregazione e violenza, oppressione e sfruttamento dei palestinesi per opera dello Stato d’Israele. Allo stesso tempo, anche questa nuova manifestazione della terza guerra mondiale produce immediatamente il richiamo a serrare le file e ricompattare i fronti. Noi non possiamo che essere dalla parte degli oppressi e quindi dei palestinesi, perché riconosciamo nella violenza degli oppressi la pretesa di mutare radicalmente il presente che li sovrasta, ma al contempo, continuiamo a ripetere ostinatamente che non ogni violenza deve necessariamente avere la forma della guerra. Come abbiamo detto e scritto a proposito della guerra in Ucraina, la politica transnazionale di pace non è semplicemente un nuovo pacifismo e nemmeno una chimera di pacificazione. Essa si colloca risolutamente dalla parte di chi diserta su entrambi i lati della barricata, delle donne che fuggono dalle zone di conflitto per non essere né soldatesse né vittime sull’altare della nazione o della religione, di tutti coloro che pur accedendo alla violenza rifiutano la logica mortifera della guerra.
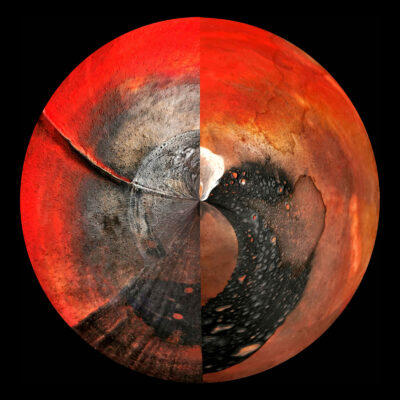
Non ci sarà nulla di lontanamente simile a una stabilizzazione in Palestina senza la fine dell’occupazione israeliana dei territori oggi assegnati ai palestinesi. Non c’è ordine e non ci sarà stabilità al confine Est dell’Europa, così come non c’è al confine Sud, finché non cesseranno le politiche di guerra e di repressione dei movimenti dei migranti. Uomini e donne migranti sbarcati a Lampedusa nelle scorse settimane negano infatti all’Europa la possibilità di imporre l’ordine razzista che Ursula von der Leyen vagheggia ormai sulle orme di Giorgia Meloni. Quelle donne e quegli uomini producono disordine non solo ai confini ma anche nel cuore dell’Europa, a dispetto di decreti che non reggono alla prova di un tribunale e di accordi firmati con il sangue. E lo fanno sfidando quel surplus di violenza che pure, sotto forma di guerra quotidiana, viene scagliata contro di loro, con lo stesso coraggio e la stessa determinazione con cui le donne non hanno smesso di lottare contro una dilagante violenza maschile.
Non c’è e non ci sarà stabilizzazione fino a quando le cosiddette politiche ambientali saranno solo e soltanto occasioni per nuovi profitti. Anche questo terreno, tuttavia, non ha nulla di liscio, come dimostrano i vecchi e nuovi problemi e le rivendicazioni che si addensano attorno agli stabilimenti americani dei big three dell’automobile. I piani del capitale si scontrano infatti con la determinazione di operai e operaie non solo a ottenere salari più alti, ma a far pagare all’impresa i costi della transizione climatica che, altrimenti, graverebbero per intero sulle loro spalle. Esiste evidentemente una contraddizione tra la contestazione del passaggio all’elettrico da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dell’auto negli Stati Uniti e le posizioni dei movimenti ambientalisti che invece richiedono l’abbandono immediato del fossile. Si tratta di riconoscere che in questa esplicita contraddizione c’è un elemento di continuità che si dà nello scontro con i piani di transizione dei padroni e la rivendicazione di un potere per decidere chi e come debba pagarne i costi. Riaffermeremo al World Congress for Climate Justice di Milano la centralità di questa tensione, perché la lotta per la giustizia climatica deve necessariamente tenere conto, e anzi valorizzare, tutti quei momenti in cui lo scontro di classe si intensifica mettendo in discussione la stabilizzazione verde della società capitalistica.
In tutte le sue diverse facce la pretesa di stabilizzazione si trova dunque di fronte insorgenze, resistenze e opposizioni più o meno organizzate di movimenti e sindacati, ma oltre a questo c’è il rifiuto ampiamente diffuso di chi non si riconosce negli attuali processi organizzativi. Proprio perché ripensare il problema dell’organizzazione su scala transnazionale è diventato ineludibile, la piattaforma del Transnational Social Strike ha chiamato un meeting a Bologna dal 27 al 29 ottobre a cui hanno già aderito 150 attivisti di collettivi e sindacati provenienti da venti paesi europei ed extraeuropei. Da diversi anni questa piattaforma è uno spazio che connette le lotte femministe e delle e dei migranti, nella logistica e nella riproduzione sociale, esperienze di lotta sindacale e di autoorganizzazione. Per organizzare le insorgenze del presente il Tss ha scelto di chiamare sciopero tutte quelle forme di insorgenza che, non solo nei luoghi di lavoro, spezzano le condizioni entro cui oggi si danno i tentativi di stabilizzazione in atto. Scioperare significa rendere la stabilità una condizione impossibile. Significa, ancora, far valere nel disordine del nostro tempo un potere che non è solo una convergenza occasionale di soggetti sociali, ma una piattaforma che amplifichi e connetta in modo continuativo le diverse insorgenze, coniugando pratiche di lotta e discorso politico, iniziative locali e processi transnazionali.
Non c’è pratica senza un discorso che colleghi la rabbia che insorge nel qui e ora con le molteplici, frammentate, difformi insorgenze che destabilizzano un ordine impossibile. Abbiamo ormai verificato che le lotte non possono esaurirsi nella loro dimensione locale, perché le nostre oppressioni ordinarie dipendono da processi transnazionali che non possono più essere ignorati, pena condannarsi all’impotenza. Proprio per questo la nostra scommessa è quella di rispondere all’organizzazione transnazionale del dominio con una piattaforma altrettanto transnazionale. La piattaforma è lo spazio organizzativo per agire in un tempo politico che non procede più necessariamente per accumulazione continua di forza, ma per salti, per esplosioni intermittenti che devono però essere intercettate per costruire una continuità politica nel tempo. Infrangere le barriere, affrontare la dimensione transnazionale: queste le parole d’ordine del meeting che si terrà a Bologna per misurarsi con una sfida che non è iniziata oggi, ma che oggi si presenta sotto il segno di un’urgenza non più rinviabile. Quest’urgenza ha per noi il volto di donne, precari, operai e migranti che rifiutano di essere un’emergenza da governare. Pretendono di essere ciò per cui hanno lottato e stanno lottando: insorgenze che reclamano un’organizzazione all’altezza del presente. Sostenere questa pretesa è per noi il valido motivo per partecipare al meeting del TSS: nell’età della stabilità impossibile, il fatto che ad organizzarci sul piano transnazionale siamo noi è qualcosa che il capitale non aveva calcolato.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




