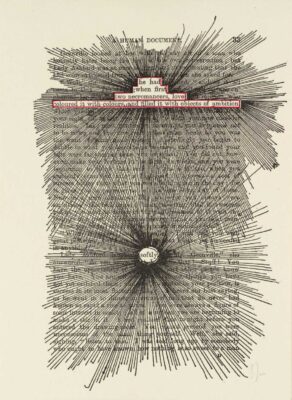
di LIA BRUNA
Il recente dibattito scatenato dalle prime applicazioni commerciali dei sistemi di IA generativa, per la prima volta accessibili al grande pubblico nel 2022, ha sciolto ogni dubbio sulla possibilità di usare le categorie marxiane per interpretare le trasformazioni sociali derivanti dall’introduzione della tecnologia nei processi di produzione culturale. Sarà opportuno provare a capire in che cosa consistono queste trasformazioni nella vita di lavoratrici e lavoratori, prendendo in considerazione le mansioni autoriali dell’industria culturale, con particolare attenzione alla traduzione editoriale, principale occupazione di chi scrive. Occorre innanzitutto distinguere tra quanto accade “a monte” e “a valle” del sistema, ossia tra addestramento della macchina e lavorazione del suo prodotto, dove prendono forma le condizioni per nuove modalità di sfruttamento del lavoro.
A monte, la preoccupazione riguarda l’utilizzo di migliaia e migliaia di opere – che contengono il lavoro di altrettante persone – necessario per il costante miglioramento operativo della macchina. A legislazione vigente, il diritto d’autore sembra lo strumento più adeguato a rivendicare la giusta remunerazione per la continua estrazione di valore dalle opere nel tempo: se i dati relativi a un’opera sono usati in un sistema di IA con finalità commerciali, ha senso che chi di quell’opera è titolare riceva un compenso (per chi lavora nello spettacolo, il cui obiettivo è vedere compensato l’utilizzo dei propri dati biometrici, la stessa funzione sarebbe svolta dal diritto all’immagine). In questa direzione vanno sia la Direttiva europea 2019/790 sul Copyright, sia il Regolamento sull’IA approvato a giugno dal Parlamento Europeo: il mondo guarda con trepidazione i risultati della cultura legislativa comunitaria, che per ora ha definito i «livelli di rischio» e imposto l’obbligo di trasparenza sui dati usati in fase di input, da pubblicare in registri riassuntivi. Rimane il dubbio sull’effettività del Regolamento – chi e come controlla la veridicità di questi registri? se si tratta di una nuova mansione da appaltare ad agenzie e collecting society, con che salario e a quali condizioni di lavoro? il costo dell’operazione sarà ritenuto sostenibile dagli interessi in gioco? – e soprattutto rimane pressoché assente, nel dibattito su quello che sarebbe giusto e ovvio rivendicare, la presa d’atto della diversa posizione di autori da un lato (illustratrici, scrittori, fumettiste, traduttori, dialoghiste, adattori, animatrici, drammaturghi, sceneggiatrici, compositori, giornalisti) e primi cessionari dall’altro (case editrici e di produzione).
Il rapporto di lavoro delle mansioni autoriali è spesso contrattualizzato esclusivamente nella forma di una cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere: questo significa che – mentre i diritti morali, ossia la paternità dell’opera, restano sempre alla persona che l’ha creata – i diritti di sfruttamento economico vengono ceduti – per un tempo limitato, a determinate condizioni e dietro «remunerazione adeguata e proporzionata» (art. 107 L. 633/1941 s.m.i.) – a chi la pubblica e la distribuisce per profitto. La necessità delle aziende produttrici di IA di addestrare i propri sistemi crea un nuovo mercato, di dimensioni potenzialmente enormi: quello dell’acquisto in blocco di opere dai primi cessionari dei diritti di sfruttamento economico. Per la prima volta, la merce rappresentata dalle creazioni del lavoro autoriale acquista un valore che prescinde dalla commerciabilità della singola opera: la quantità e la varietà delle opere possedute rappresenta, di per sé, un valore. Non è difficile immaginare, in un futuro prossimo, operazioni di acquisto in massa di interi cataloghi di opere, usate per addestrare sistemi di IA da impiegare nella creazione di prodotti che, naturalmente, i titolari (e gli utilizzatori) di tali sistemi vorranno considerare come nuove opere, sostenendo di possedere su di esse diritti esclusivi. In questo quadro, l’enorme asimmetria di potere economico e contrattuale che sussiste tanto tra le Big Tech e i primi cessionari, da un lato, quanto tra i primi cessionari e gli autori e le autrici, dall’altro, favorirà comportamenti abusivi “a cascata”, dove chi, col proprio lavoro, ha creato l’opera è l’anello più debole della catena. Ciò è particolarmente vero per chi crea, potremmo dire, “su commissione”, ossia autori e autrici per cui l’opera è in primo luogo prodotto di lavoro e mezzo di sussistenza e che quindi hanno meno potere negoziale per rifiutare condizioni contrattuali inique e compensi da fame.
La tutela del lavoro autoriale, in definitiva, passa necessariamente dal rapporto con i primi cessionari: la possibilità di cedere i diritti per finalità di addestramento delle macchine dovrà formare oggetto di accordi espressi, che riconoscano all’autore o all’autrice un compenso equo e proporzionato. Soprattutto, è fondamentale cominciare a dire che i contratti stipulati in passato, prima che la tecnologia creasse le condizioni per le attuali possibilità di sfruttamento economico, non comprendevano questo diritto, che altrimenti verrà sfruttato senza essere retribuito.
A valle, la frammentazione della manodopera rende ardua tanto la sindacalizzazione quanto il monitoraggio del mercato del lavoro e delle sue pratiche. Mi atterrò quindi al caso della traduzione per l’editoria libraria italiana, provando a inquadrare la questione nel panorama storico della rivoluzione informatica e delle sue conseguenze sul lavoro intellettuale, a partire da due esempi “adiacenti” alla traduzione editoriale: la redazione e la traduzione tecnica. Se da un lato è innegabile che i processi di esternalizzazione delle redazioni, con lo svuotamento delle case editrici e la precarizzazione di centinaia di persone, sono stati resi possibili, oltre che dalle riforme del diritto del lavoro, dall’accessibilità dei software di videoscrittura, dall’altro non si può prescindere dall’esperienza di chi, occupandosi di traduzione tecnica (che interessa i testi in cui l’elemento creativo non è consentito), ha già vissuto sulla propria pelle l’automazione del processo traduttivo: senza i CAT tools oggi sarebbe impossibile raggiungere velocità e standard di produzione sufficienti a guadagnarsi da vivere. CAT sta per computer assisted translation: il sistema si basa su corpora cumulativi di parole e frasi pre-tradotte, che consentono uniformità e rapidità nella traduzione di testi strutturalmente ripetitivi; oggi è integrato dalle reti neurali alla base dell’IA generativa, e nel mansionario del traduttore tecnico è stabilmente entrato anche il «post-editing», cioè la revisione di testi pre-tradotti dalla macchina.
Difficile dire quanto questa pratica sia diffusa nel mondo della traduzione editoriale. Se fino a ieri il bassissimo costo medio della manodopera autoriale rendeva poco appetibile l’investimento degli editori in quella direzione, oggi non è più così. A inizio 2023 cominciano a circolare voci di case editrici che vogliono «sperimentare» l’uso di IA per pubblicare testi in traduzione, di cui al traduttore viene commissionata la revisione: pare si tratti per lo più di realtà piccole e poco radicate sul mercato, che rispetto all’editoria tradizionale si muovono con maggiore agilità tra queste pratiche ancora poco formalizzate. Tuttavia, dai comunicati estivi degli editori associati e dall’attivazione di corsi ad hoc per i soci non è difficile immaginare che la pratica possa presto prendere piede in modo sistematico, soprattutto per alcuni generi come la varia, certa saggistica e magari anche la narrativa da edicola. È ragionevole pensare che, se anche l’applicazione fosse limitata a questi ambiti, le conseguenze interesserebbero l’organizzazione dell’intera filiera.
Si configura così la nuova mansione di chi rimette mano ai prodotti generati da IA, che senza intervento umano non sarebbero commercializzabili: una mansione altamente specializzata, che richiede le stesse competenze dell’omologo autoriale tradizionale – oltre a quelle necessarie a interagire con la macchina – e comporta un carico di lavoro più intenso, ripetitivo e logorante. Si può immaginare che il discorso valga per tutte le filiere dell’industria culturale (viene in mente l’illustratore che interviene a cancellare le ventordici dita dalle mani nei ritratti di Midjourney), ma limitiamoci al post-editing applicato alla traduzione editoriale: le associazioni di categoria francesi e tedesche – che da tempo conducono un prezioso lavoro di documentazione e analisi del fenomeno, nel contesto di una rete europea di associazioni di traduttori letterari – hanno chiesto a un gruppo di persone di lavorare sullo stesso testo, alcune traducendo il testo fonte, altre rivedendo la pre-traduzione. I risultati sono rivelatori: il tempo di lavoro è pressoché equivalente, mentre i testi prodotti a partire dalla pre-traduzione sono più simili tra loro e piegati sulle soluzioni della macchina. Al di là del panico per l’impoverimento della lingua letteraria, sarà utile formulare alcune ipotesi sulla possibile ristrutturazione dei processi produttivi.
Se, per chi conosce bene la lingua di partenza, lavorare su un testo pre-tradotto non è più veloce ed è più impegnativo (si tengono sotto gli occhi tre testi invece che due – l’originale, quello pre-tradotto e quello da consegnare – e la concentrazione viene spostata su aspetti meccanici che sottraggono energia al necessario elemento creativo), allora la macchina serve soprattutto a maneggiare lingue che si conoscono poco: così, da un lato, aumenta la domanda di figure sì specializzate in traduzione editoriale, ma non per forza qualificate per la specifica lingua di partenza, rendendo tutti più sostituibili; e dall’altro si riduce l’occupabilità di chi lavora dalle lingue cosiddette «minori» o non veicolari, che oggi si mantiene anche grazie ad attività come la lettura e la schedatura di testi stranieri di cui l’editore italiano, da solo, non può giudicare la commerciabilità (uno degli argomenti a favore della diffusione dell’IA in traduzione è la «democratizzazione» della comunicazione da e verso queste lingue «minori»: qui però sembra che la disintermediazione tecnologica non faccia che aggravare la dipendenza della produzione libraria dai meccanismi di mercato, finendo comunque a favorire la traduzione da e verso le lingue in cui l’IA funziona meglio perché, banalmente, ha molte più informazioni.)
Inoltre, come i programmi di videoscrittura hanno consentito di ridurre i numero di giri di bozze (con risultati discutibili), è possibile che l’uso dell’IA in editoria elimini la necessità della revisione tradizionale, essendo traduzione e revisione potenzialmente comprese nel post-editing, con il doppio risultato di dequalificare chi traduce e soppiantare chi rivede. A questo proposito va detto che il post-editing sembra distinguersi anche dalla revisione tradizionale, dove chi rivede si muove usando le stesse strategie neuropsichiche di chi ha tradotto, ne riconosce il processo mentale, può interagire sollecitando, interrogando, formulando soluzioni alternative: tutte operazioni impraticabili con la macchina, di cui, a differenza che con la calcolatrice, è impossibile rifare i calcoli a mano.
Mentre si cominciano a tracciare le dovute connessioni con l’esperienza di chi lavora nelle altre filiere, da queste premesse è legittimo desumere che, al di là degli anatemi sulla fine dell’umano, qui siano in gioco le condizioni di vita di centinaia di lavoratrici e lavoratori. Se davvero si vuole arginare il fenomeno, bisogna rendere meno conveniente l’uso dei sistemi di IA da parte delle imprese, pretendendo la giusta retribuzione delle nuove mansioni. Eppure c’è chi pensa che contro la «good enough quality» l’unica soluzione sia mantenere un livello professionale altissimo e battersi a fianco dei committenti «virtuosi» per una definizione dello statuto giuridico dei prodotti generati da IA che escluda la loro equiparazione alle opere dell’ingegno. Si tratta di posizioni assai pericolose, che sottovalutano tanto le potenzialità tecniche della macchina quanto l’interesse delle aziende a usarla per ridurre i costi di produzione: una battaglia di retroguardia, illusa della verità di una differenza tutta sovrastrutturale tra editoria «di qualità» ed editoria commerciale, con l’unico risultato di distinguere dal resto del mondo chi potrà continuare a definirsi «autore». Magra consolazione, se bisogna competere nello stesso mercato dove operano tutti gli altri, per poi magari finire a svolgere quelle stesse mansioni tanto snobbate, per mettere insieme il pranzo con la cena. C’è poco da fare, sulla qualità aveva ragione René Ferretti. L’alternativa, soprattutto se ne va della salvezza dell’umanità e dell’arte, non è lavoro: è martirio.
liabruna.traduttrice@gmail.com
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




