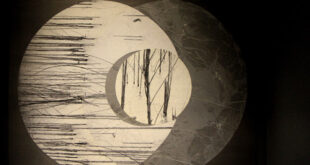di MAURIZIO RICCIARDI e PAOLA RUDAN
 Pubblicato su «Il Manifesto» del 24 settembre 2015 con il titolo Lo smarrimento del partigiano.
Pubblicato su «Il Manifesto» del 24 settembre 2015 con il titolo Lo smarrimento del partigiano.
La lotta partigiana contro il nazifascismo è un fatto storico collocato in un passato ormai piuttosto lontano, commemorato ogni 25 aprile alla ricerca di ciò che al suo interno può essere considerato ancora attuale, degli insegnamenti che se ne possano trarre, dei comportamenti che si devono tenere di fronte al fascismo. Il momento della liberazione è così assunto come il punto culminante della scelta partigiana. Se però di quell’esperienza vogliamo rintracciare la contemporaneità oltre ogni rituale celebrazione, se vogliamo aderire fino in fondo al senso di un tempo che pure è cronologicamente così distante, è all’8 settembre del 1943 che dobbiamo guardare.
Il volume di Matteo Cavalleri La Resistenza al nazi-fascismo. Un’antropologia etica (Mimesis, 2015, 234 pp., 20 €) adotta con coerenza questo spostamento dello sguardo, questa deviazione consapevole dai calendari e dalle commemorazioni. La storia è nota. L’8 settembre la fuga dei vertici politici e militari del governo in seguito alla proclamazione dell’armistizio con le forze alleate produce un vuoto normativo e un profondo smarrimento. Con il disorientamento, però, sorge anche la consapevolezza della possibilità di un nuovo inizio. Riprendendo la lezione di Alain Badiou, Cavalleri legge quella data come un «evento», cioè come il «principio di una procedura di verità» che costringe «a decidere una nuova maniera d’essere» e impone di rimanere fedeli a quella scelta. Si tratta di essere fedeli a qualcosa che non è dato storicamente, come una tradizione o un qualsiasi passato, ma può divenire reale solo nel futuro. L’orizzonte normativo che i partigiani si assumono il compito di costruire soppianta la coazione all’ubbidienza su cui si basavano le istituzioni fasciste, ma quell’orizzonte ancora non esiste e può essere scoperto solo durante la sua realizzazione pratica. Se il fascismo è la negazione della stessa possibilità di scegliere, la scelta partigiana è prima di tutto il ritorno a quella possibilità, che il fascismo non è riuscito a cancellare.
Prima dell’8 settembre alcune delle condizioni di questa scelta erano state tracciate da una generazione antifascista – quella di Bilenchi e Caproni, di Moravia, Pratolini e Vittorini – la cui esperienza si radicava nella Prima guerra mondiale e si esprimeva nell’antiautoritarismo, nell’antimassificazione, nella critica della società industrializzata e tecnologica e nella tendenza libertaria. Come traspare dai racconti di Fortini e Rossanda, però, la generazione cresciuta col fascismo, «la generazione degli anni difficili», è costituita «da soggetti che hanno dovuto trovare forme per salvare se stessi dal ricatto continuo della propria biografia». Per questo la categoria di «moralità» permette di portare alla luce tanto l’impatto della Resistenza quanto i suoi effetti «antropologici» su una generazione digiuna di politica. La moralità sta nella tensione normativa che innerva l’azione, nell’anelito di libertà che si oppone «a un dispositivo di potere mirante alla negazione di qualsiasi possibilità di disobbedienza». Il rifiuto è il principio attorno al quale si consolida una dimensione condivisa: l’esperienza della Resistenza è esperienza di una solitudine inestricabilmente connessa alla responsabilità collettiva, il cui senso si definisce nel riconoscimento reciproco che permette di superare l’intenzione individuale in nome di un registro etico superiore.
 Soprattutto per la generazione di letterati che si è formata con la Resistenza, il momento estetico è sincronico rispetto a quello politico e la scrittura, il gesto di testimonianza, deve destreggiarsi tra due tensioni opposte: quella di chi vuole immediatamente dimenticare la Resistenza e quella di chi vuole farne un monumento da celebrare. Cavalleri analizza una cospicua mole di romanzi resistenziali e altrettanta memorialistica, mostrando che la ricerca estetica si trova costantemente presa nel gioco tra le informazioni che deve comunicare e la scelta che vuole rendere contemporanea. Se le prime si esauriscono nella puntualità di ciò che viene narrato, la seconda non patisce la consunzione del tempo. La narrazione dell’esperienza vissuta restituisce qualcosa che non è stato sterilizzato dalla coscienza e che può essere recuperato, attraverso la scrittura, solo in termini politici e collettivi. È così che, rileggendo il Sentiero dei nidi di ragno nel 1964, Calvino può affermare: «più che come un’opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale di un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva». Per Calvino l’esperienza della Resistenza «suscita una coralità narrativa diffusa». Come la scelta per la montagna, per la clandestinità, per la lotta armata, la «scelta per la scrittura» è mossa da una pulsione di verità e il senso di inadeguatezza del narratore di fronte all’esperienza da narrare corrisponde a quello del partigiano di fronte all’evento da esperire. La scelta va continuamente ribadita per catturare il presente al di là del clamore dell’attualità: se all’istantanea dell’informazione corrisponde la celebrazione monumentale della Resistenza come fatto storico, alla narrazione come ricerca costante di una possibilità di «parola liberata» corrisponde la presenza della Resistenza come evento.
Soprattutto per la generazione di letterati che si è formata con la Resistenza, il momento estetico è sincronico rispetto a quello politico e la scrittura, il gesto di testimonianza, deve destreggiarsi tra due tensioni opposte: quella di chi vuole immediatamente dimenticare la Resistenza e quella di chi vuole farne un monumento da celebrare. Cavalleri analizza una cospicua mole di romanzi resistenziali e altrettanta memorialistica, mostrando che la ricerca estetica si trova costantemente presa nel gioco tra le informazioni che deve comunicare e la scelta che vuole rendere contemporanea. Se le prime si esauriscono nella puntualità di ciò che viene narrato, la seconda non patisce la consunzione del tempo. La narrazione dell’esperienza vissuta restituisce qualcosa che non è stato sterilizzato dalla coscienza e che può essere recuperato, attraverso la scrittura, solo in termini politici e collettivi. È così che, rileggendo il Sentiero dei nidi di ragno nel 1964, Calvino può affermare: «più che come un’opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale di un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva». Per Calvino l’esperienza della Resistenza «suscita una coralità narrativa diffusa». Come la scelta per la montagna, per la clandestinità, per la lotta armata, la «scelta per la scrittura» è mossa da una pulsione di verità e il senso di inadeguatezza del narratore di fronte all’esperienza da narrare corrisponde a quello del partigiano di fronte all’evento da esperire. La scelta va continuamente ribadita per catturare il presente al di là del clamore dell’attualità: se all’istantanea dell’informazione corrisponde la celebrazione monumentale della Resistenza come fatto storico, alla narrazione come ricerca costante di una possibilità di «parola liberata» corrisponde la presenza della Resistenza come evento.
Cavalleri chiarisce con intelligenza che la scelta partigiana non può essere intesa come puro volontarismo. Le parole di Camillo de Piaz rendono limpidamente il senso dell’ineliminabile connessione tra scelta e situazione: «che cosa vi può essere di più grande, di più storicamente ed esistenzialmente pregnante, di una necessità che assume la dimensione di una scelta»? Dal punto di vista del partigiano, ciò significa scegliere la necessità del suo tempo presente, fino al punto da sovvertirlo. È questa dimensione della scelta, che non nega la determinatezza storica ma cambia il segno della sua energia, ciò che permette di vedere nel partigiano non un oltreuomo, ma – con le parole di Fenoglio – la grandezza di un uomo «quando è nella sua normale dimensione umana». Ed è in definitiva proprio qui che si stabilisce una fondamentale distanza antropologica tra il partigiano e il nazifascista. Il primo non è una figura definita e conclusa, ma fa politica dipendendo da altre figure che lo sostengono e gli danno significato e non dimentica mai di avere di fronte un uomo anche se si tratta del fascista o del nazista che ha di fronte. L’ariano, al contrario, è una rappresentazione senza resti di un’idea di uomo che si pretende superuomo, che satura di sé anche la vittima della sua violenza. Una violenza che, sia per l’SS sia per la sua caricatura repubblichina, non ha bisogno di legittimazione, è mero esercizio, mentre per il partigiano è terribile costrizione. La violenza non coincide con la politica, ma è per il partigiano la possibilità di rifondare l’orizzonte normativo che ha perduto la propria funzione di preservazione della vita, perché «l’ordine fascista e la guerra hanno ributtato la normalità della morte, del dare la morte, alla quotidianità». Così, è incolmabile anche la distanza delle due diverse concezioni della morte. Le narrazioni partigiane sono costantemente segnate dalla ricerca di un rapporto con i compagni morti. Non si tratta solamente della necessità di dare memoria, ma piuttosto di una sorta di infinita nostalgia per chi non ha potuto vivere fino in fondo le possibilità aperte dalla scelta partigiana, della «simpatia» verso coloro con i quali si è condivisa quella scelta con tutti i suoi rischi. In nessun caso, comunque, questo ricordo etico si traduce nell’ideologia fascista della bella morte, né tantomeno nella didascalica celebrazione di un pro patria mori che permetterebbe una revisionistica associazione tra i caduti della Resistenza e quelli di Salò. Se il partigiano non è niente più che un uomo, bisogna allora riconoscere che, piuttosto che morire, avrebbe preferito vivere. Il partigiano non si è immolato eroicamente per dei valori, ma si è assoggettato alle conseguenze della scelta di libertà che aveva fatto.
Se il partigiano non è niente più che un uomo, tuttavia, bisogna riconoscere anche che non è così diverso dal fascista, o meglio non lo era prima che la scelta lo investisse con tutto il peso della sua libera necessità. L’8 settembre conteneva anche il rischio di «farsi inglobare dal magma normalizzante della violenza del nemico, di smarrirvi l’ultima possibilità di una nuova antropologia». L’8 settembre può essere visto come un’«origine», perché è un’interruzione e un’emergenza: è una novità che annuncia uno scarto. La scelta partigiana introduce nella storia un mutamento di percezione e di prospettiva che interrompe anche la geografia, perché lo stesso paesaggio può essere tanto protettivo quanto impervio e minaccioso, ricoperto del fango con il quale Fenoglio dà il senso della dissoluzione etica dei luoghi familiari e del sentimento di abbandono che coglie il partigiano dopo l’8 settembre. Questo mutamento sempre possibile rimanda al carattere specificamente politico della scelta partigiana che per Cavalleri è anche il punto di incontro tra Resistenza e filosofia. La scelta partigiana non è un’adesione al registro dell’opinione, ma cambiare lo sguardo sul presente per abbracciare la rottura introdotta dall’evento. Essa è politica perché si rivolge contro le apparenze, senza cioè accettare i comportamenti imposti dal regime fascista e dalla sua propaganda, senza rassegnarsi al comune senso del disastro prodotto dall’8 settembre e, soprattutto, senza accomodarsi nell’attesa di tempi migliori. Questa scelta di parte indica una specifica idea della politica, intesa come presa di posizione, come esposizione. Essa non è una semplice militanza di parte, ma il farsi carico della situazione generale stando da una parte. Il senso profondo del termine partigiano mostra perciò la via per comprendere in che senso un evento passato come la Resistenza possa essere a noi contemporaneo, non come ricordo o ripetizione, ma come individuazione nella condizione presente della parte da cui stare. A questo evento passato non si deve essere fedeli. Per riconoscerne la contemporaneità si può solo operare una scelta di parte in grado di rispondere alle necessità del presente.
Solo l’accesso a questa contemporaneità permette di comprendere «la felicità esperita dal partigiano mentre sta ancora lottando per la felicità», di cogliere la via verso la giustizia anche nei momenti di più buia violenza. È questa contemporaneità, che è a un tempo presenza e distanza, che permette di afferrare fino in fondo le parole di Teresa Cirio: «si rischiava la morte, però talmente c’era la gioia di vivere! […] Non ho mai vissuto una vita bella così. Sofferenza sì, ma una cosa»! La gioia di cui parla questa donna partigiana è la stessa che risuona nelle danze e nei colpi di mortaio delle donne di Kobane. Una gioia che non trova alcuno spazio nell’estetica certa di sé di un antifascismo ridotto all’iterazione, sempre uguale a se stessa, di una resistenza che ha dimenticato la sua scelta di parte.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione