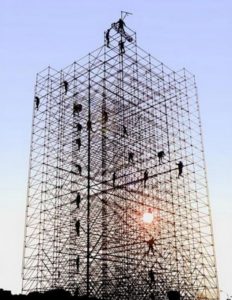L’«entusiasmo» per il presunto aumento dell’occupazione e della stabilità dei rapporti di lavoro prodotto dal Jobs Act è durato ben poco. Nel primo trimestre del 2016 i dati rivelano un netto calo di assunzioni in coincidenza della riduzione degli sgravi fiscali. L’aumento delle assunzioni è infatti meno del 33,4% rispetto al primo trimestre del 2015. Dati alla mano è evidente che la crescita occupazionale è stata solo un temporaneo abbaglio. Se lo scorso anno l’esonero contributivo era pari al 100% per i primi tre anni, da gennaio 2015 è del 40% per soli due anni. Insomma, le assunzioni o le trasformazioni contrattuali sono strettamente legate alla consistenza dell’incentivo ma, laddove non c’è più risparmio totale, il contratto a tutele crescenti chiaramente non è più appetibile. Del resto, un’alta percentuale dell’aumento rilevato consiste nella conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tutele crescenti, dovuti agli sgravi fiscali previsti per il primo periodo della loro introduzione. Gli sgravi sono infatti riservati alle cosiddette «nuove assunzioni», di nome ma non di fatto. I cosiddetti «furbetti del Jobs Act» sono stati smascherati qualche mese fa, quando l’INPS si è accorto che molti lavoratori erano stati licenziati per poi essere riassunti in un secondo momento, affinché le aziende potessero godere della decontribuzione. In alcuni casi, il giochetto messo in pratica consisteva nell’indurre i lavoratori a licenziarsi, per assumerli poi con un’altra azienda o cooperativa creata ad hoc e operativa nello stesso luogo di lavoro.
Il passaggio da contratti a tempo determinato al contratto a tutele crescenti viene venduto come un successo ma, oltre a non costituire un aumento reale dell’occupazione, non garantisce nessuna crescita della stabilità del lavoro. Di per sé solo la retorica del governo può presentare le tutele crescenti come tempo indeterminato, dato che, con la liberalizzazione dei licenziamenti, di fatto non c’è più distinzione rispetto a un contratto precario, almeno per i primi tre anni. Tanto più difficile parlare di una crescita del lavoro stabile dal momento che, nel complesso, più del 63% dei nuovi assunti nei primi nove mesi dell’anno ha un contratto temporaneo, grazie alla liberalizzazione dei contratti a tempo determinato sul totale degli assunti. Se una forma contrattuale non funziona più a dovere, ovvero senza bonus o con un bonus ridotto, c’è comunque la possibilità di sperimentarne altre non prive di incredibili vantaggi per incrementare utili e profitti. A prescindere dalla crisi, nel momento in cui assumere con regolare contratto non sia più ritenuto appetibile, le aziende iniziano a percorrere la strada tutta in discesa dei voucher. Non è un caso che le percentuali di buoni lavoro venduti crescano vertiginosamente ogni mese: siamo a +45,6% rispetto all’anno scorso. Si tratta di quella riserva di lavoro compiutamente informalizzato dal punto di vista contrattuale che sta diventando in tutti i paesi d’Europa – si pensi ai mini-jobs tedeschi e agli zero hours contract in Inghilterra – una componente fondamentale del mercato del lavoro. In origine gli stessi voucher sono stati introdotti sulla scia di altri paesi europei come Belgio – che pare sia l’unico paese dove è prevista l’assunzione dei lavoratori a voucher o meglio a «titrens services» dopo un periodo di lavoro che va da tre a sei mesi –, Austria, Regno Unito e Francia. Si tratta di un sistema di pagamento che ha origine nel lavoro educativo e di cura – come contributo monetario che viene dallo Stato o dall’azienda per comprare lavoro precario per colmare le falle del welfare. In Francia e in Belgio possono essere utilizzati per pagare lavori di cura e domestici laddove le famiglie non riescono a sostenere contratti regolari per assumere lavoratori e lavoratrici «in prestito», che comunque devono essere dipendenti di imprese o associazioni specifiche. L’Italia non si è semplicemente limitata a copiare, è andata oltre!
Se nel Nord Europa l’utilizzo dei voucher è rimasto limitato ai servizi sopra menzionati, in Italia si possono utilizzare in ormai tutti i settori. Con il rialzo del tetto massimo annuale di salario ottenibile tramite voucher si è fatto un passo avanti nella loro diffusione e per molti è ormai l’unica maniera possibile di lavorare. Per fronteggiare le irregolarità che questo metodo comporta, il governo promette di attuare delle modifiche ai decreti legislativi. Una vera normalizzazione della precarietà richiede delle tutele ad hoc contro gli abusi. Basta introdurre sanzioni – che vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 2400 euro – per quei padroni che non comunicheranno per tempo, ovvero 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati del lavoratore del giorno, tempi e luogo di lavoro e il gioco è fatto. Ma chissà se questi padroni pagheranno mai una multa: sarebbe necessaria un’operazione capillare di controllo nei fatti inattuabile. L’unico vincolo è quello di non superare il tetto massimo di 5000 euro annui, ma il problema non si pone dal momento che parte della prestazione viene di solito elargita in nero. Si può ricevere un solo voucher anche se si è lavorato per più di un’ora e recuperare il resto in nero. Il padrone potrà quindi disporre di un esercito di lavoratori subordinati senza assumerli e soprattutto senza porsi il problema di doverli un giorno licenziare, perché deve adempiere solo una formalità: acquistare i buoni. Anche dove il voucher non è impiegato, spesso viene evocato o preso a misura per abbassare i salari: il valore di 7,50 euro netti diventa sempre più spesso il livello di paga oraria in quelle aziende dove i salari sarebbero più alti. In questo modo, i voucher stanno diventando un modello da imitare anche laddove si lavora, per esempio, a prestazione occasionale. Una sorta di salario minimo informale e al ribasso. Lungi dall’essere una forma di messa in regola della piaga del lavoro nero o stagionale, la voucherizzazione è piuttosto l’ultima generazione della precarietà, un modello non solo italiano per portare avanti un’informalizzazione del lavoro che punta esplicitamente a restringere i margini d’azione ai lavoratori. A sostegno della farsa dell’aumento dell’occupazione, Renzi ha portato il dato dell’aumento delle richieste di disoccupazione, scese del 28,6% nei primi due mesi del 2016. È evidente che lui è il re dei furbetti di cui sopra: dato che i voucher non danno diritto a nessuna indennità di disoccupazione, quei dati indicano la durezza di un regime del salario che non investe solo il rapporto di lavoro ma anche il welfare e il reddito.
C’è chi alla luce di tutto ciò attribuisce al governo una scarsa lungimiranza e una debole politica economica: il Jobs Act dovrebbe essere affiancato da investimenti e programmi per la crescita. C’è chi mette in guardia dal fatto che i dati su disoccupazione e occupazione hanno un significato radicalmente diverso nel momento in cui l’aumento di occupazione è una fluttuazione temporanea in un regime di precarietà. Di certo non si può misurare il fallimento o meno del Jobs Act sulla base delle intenzioni dichiarate da chi l’ha messo in atto. Lo sappiamo che l’obiettivo non era la stabilizzazione del mercato del lavoro, ma la messa in opera a regime della precarietà, la garanzia di una flessibilità grazie alla quale le aziende possano adeguare ai loro bisogni la quantità e il pagamento del lavoro, il risparmio netto di spesa pubblica. Questo è il programma per la crescita del governo e dell’Unione Europea, com’è evidente dalla strategia Europa 2020 di coordinamento delle economie politiche degli Stati membri, cioè una serie di target da raggiungere entro il 2020 attraverso riforme al ribasso del diritto del lavoro e del welfare.
L’effetto Jobs Act in quest’ottica non può essere considerato su un piano solamente nazionale: esso va collocato nella dimensione europea in cui materialmente si dà. Quello che si sta costituendo è un regime del salario europeo che deve essere compreso e contrastato nella sua giusta scala. Si tratta di un piano che è imposto dalla presenza di una serie di direttive europee e da un potere di ricatto finanziario che la UE esercita sugli Stati. Le direttive sono chiare: l’aumento di occupabilità va prodotto abbassando i salari, in tutte le loro componenti, con tagli al welfare e premendo sui ritmi e le ore di lavoro. La flessibilità da garantire per la crescita non è solo l’agibilità del licenziamento e la sua monetizzazione, ma un risparmio netto sul costo del lavoro, tanto per i padroni quanto per lo Stato. Il Jobs Act va dunque considerato insieme alla loi travail francese, alle riforme Hartz in Germania, alla regolazione al ribasso di welfare e salari previsto dal governo Cameron alla vigilia del referendum sul Brexit, all’austerity package greco e a molte altre misure messe in opera negli Stati europei. Emblematico in questo senso è lo scarto tra dichiarazioni come quelle del presidente Juncker secondo cui la loi travail è il «minimo che si possa fare» per rispettare le necessità tecniche della UE e lo sciopero sociale che sta mobilitando la Francia, contro il carattere palesemente di classe di questa necessità tecnica che si presume neutrale. È evidente sulla pelle di chi si giocano gli obiettivi dell’Agenda 2020. Il piano europeo, del resto, non è dettato solo dalle politiche economiche ma anche dall’organizzazione sempre più transnazionale del lavoro e della produzione: delocalizzazioni e catene del valore hanno una diretta influenza nel locale. Infine, il piano europeo è imposto a partire dalla mobilità crescente del lavoro: migranti interni ed esterni praticano quotidianamente lo spazio europeo come terreno di lotta. Tanto il coordinamento istituzionale auspicato per garantire lavoro povero e disponibile quanto la possibilità di giocare a proprio vantaggio le differenze tra salari e condizioni da parte dei lavoratori sono elementi costitutivi del nuovo regime del salario europeo.
Inoltre, il regime del salario europeo ci obbliga a guardare, attraverso e oltre le misure legislative, al modo in cui di fatto si dispiega il ricatto del salario, dentro e fuori i posti di lavoro, sul piano nazionale e attraverso i confini. In questo le misure per tagliare il welfare e utilizzarlo di fatto come uno strumento per accrescere la disponibilità al lavoro e per piegare la mobilità solo a vantaggio dei padroni sono centrali. Attraverso la concessione o il ritiro di misure di welfare si crea una stratificazione di condizioni non solo contrattuali, ma anche di tutela, a seconda che si possieda o meno un permesso di soggiorno, che si abbia o meno una famiglia, di quanti mesi di lavoro arretrato da cui dipendono eventuali indennità di licenziamento o disoccupazione, che rende estremamente frammentato l’attuale panorama in cui la precarietà è la norma. Dovremo dunque indagare i diversi modi in cui il regime del salario europeo esercita il suo dominio sulla vita di milioni di uomini e donne, europei e migranti. Dovremo valorizzare le strategie di insubordinazione che a livello individuale e collettivo sono messe quotidianamente in pratica per opporsi a quel regime. Dovremo avere la consapevolezza che, se l’attacco è europeo, il contrattacco dovrà essere altrettanto europeo. Se il ricatto del salario si gioca tanto dentro quanto fuori dai luoghi di lavoro, si tratta di intaccare quel rapporto di dominio in tutte le forme in cui questo si esercita. Muoversi verso uno sciopero sociale transnazionale – come si farà il prossimo 11 giugno a Parigi con l’assemblea della Transnational Social Strike Platform a Place de la République – significa accumulare potere e mettere in comunicazione i frammenti dell’attuale universo di precarietà, anche costruendo un sapere e un discorso che attraversi i confini e sia all’altezza delle attuali trasformazioni.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione