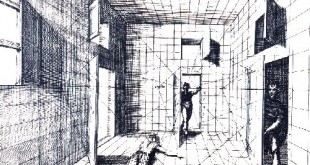→ Inglese
→ Tedesco (ringraziamo per la traduzione Interventionistische Linke Bielefeld)
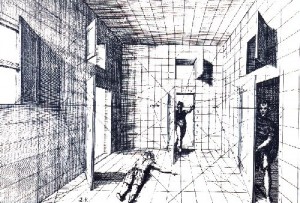 Il primo maggio è passato, lasciando dietro di sé qualcosa di più delle macchine bruciate, delle vetrine rotte, degli abiti neri abbandonati per strada. Oltre all’Expo trionfalmente aperta, il primo maggio lascia dietro di sé l’immagine plastica di un movimento che, nonostante sia riuscito a mobilitare 30.000 persone per la Mayday, si scopre politicamente impotente.
Il primo maggio è passato, lasciando dietro di sé qualcosa di più delle macchine bruciate, delle vetrine rotte, degli abiti neri abbandonati per strada. Oltre all’Expo trionfalmente aperta, il primo maggio lascia dietro di sé l’immagine plastica di un movimento che, nonostante sia riuscito a mobilitare 30.000 persone per la Mayday, si scopre politicamente impotente.
Alla fine è successo quello che tutti prevedevano, anche se molti avevano detto di volerlo evitare: la logica dell’evento si è imposta su quella del processo, della costruzione, dell’accumulazione e della condivisione di forza. Ora scoprire che i media mainstream si comportano da media mainstream è quanto meno fuori luogo. Ora il botta e risposta contabile sui costi di Expo paragonati ai costi dei danneggiamenti lascia francamente il tempo che trova. Ora risolvere tutto facendo appello alle ragioni della spontaneità arrabbiata è quanto meno insufficiente. Ciò che è successo non può essere risolto grazie a un’estetica del riot che non riesce a coprire i limiti collettivi di progettualità politica, anche perché la definizione corrente di riot si avvicina sempre più pericolosamente a quella di una rivolta magari intensa, ma istantanea e destinata a essere riassorbita senza particolari problemi dall’oggettiva e dispotica supremazia militare e simbolica dello Stato. Se il riot esiste solo nel giorno in cui avviene, a cosa serve il riot?
Sarebbe però limitativo ricondurre i limiti di azione politica che si sono mostrati in piazza solo a ciò che è successo in piazza. Forse vale la pena ripensare l’intero discorso prodotto per l’occasione dell’Expo negli ultimi mesi. A noi pare evidente che se, di fronte allo slogan «Nutrire il pianeta», la risposta è il veganesimo coatto di certi centri sociali, difficilmente si riesce a opporre un discorso globalmente efficace alle chiacchiere edificanti che scorrono e scorreranno attorno all’Expo. Evidente è invece la difficoltà di produrre un discorso politico all’altezza dell’occasione. Il movimento italiano sembra pagare un suo specifico e presuntuoso provincialismo rispetto al quale non è riuscita a stabilire un contrappeso significativo nemmeno la presenza attiva all’interno di reti internazionali, come è stata per molti di noi l’esperienza di Blockupy per la contestazione della Bce a Francoforte. Sarebbe necessario, infatti, cogliere l’occasione dell’Expo, in modo da sollevare e far agire argomenti in grado di opporsi pubblicamente alla celebrazione del cibo come merce globale. Invece non siamo riusciti finora nemmeno a lasciar intravedere un punto di vista precario, migrante e operaio oltre che sullo sfruttamento del lavoro dentro all’Expo, anche su un tema che non riguarda solamente come si mangia in Italia o in Europa, ma anche e soprattutto chi mangia, quanto e quando in molte altre zone del mondo. Sarebbe letale prendere sul serio i proclami altisonanti di Renzi, che vogliono a tutti i costi fare dell’Expo una questione italiana. Abbiamo invece assistito a proposte e dibattiti su come dovrebbe essere Milano in questi sei mesi, su come ci si dovrebbe comportare nel cortile di casa, sulla dieta politicamente più appropriata. Il tema della città è oggi certamente centrale, ma lo è nella sua scala globale, non nel qui ed ora delle singole identità cittadine. Il grande capitale multinazionale costruisce una vetrina mondiale, coloratissima e frequentatissima, per dire che sì, c’è magari qualche problema, ma che a breve darà da mangiare a tutti. Noi, che non abbiamo nemmeno approssimato un discorso realistico sulla questione globale della riproduzione materiale dell’esistenza di alcuni miliardi di poveri, precari, migranti e operai, scambiamo quattro vetrine del centro di Milano per le vetrine «simbolicamente» più rilevanti. Che poi le vetrine prescelte e le azioni compiute siano sempre le stesse da anni, la dice lunga sull’indifferenza per un’occasione che dovrebbe invece essere colta, proprio per la sua complessità e per il suo carattere immediatamente globale.
Non stupisce dunque che ora, dopo la Mayday, ci troviamo a cercare il giusto equilibrio tra conflitto e consenso, in un modo che però rischia implicitamente di separarli. Ci sono alcuni che praticano il conflitto, per una rabbia più profonda o per una maggiore intensità politica, e altri che non lo fanno. Non si capisce bene se questi ultimi si trovino in una sorta di anticamera della lotta, dalla quale possono imparare come ci si dovrebbe comportare, o se invece sono ridotti semplicemente alla platea che dovrebbe approvare i comportamenti altrui. Parlare di consenso e conflitto ha senso nella misura in cui si sovrappongono quotidianamente e non vengono evocati solamente quando riguardano i comportamenti di piazza. Riservare il conflitto allo scontro con la polizia, con le vetrine e con le macchine non restituisce nemmeno lontanamente il livello di violenza e i sordi livelli di conflitto che si dispiegano quotidianamente nei luoghi di lavoro, sulle vie delle migrazioni e nei quartieri. Una violenza e un conflitto che non sono solo subiti passivamente, ma anche praticati con intelligenza e continuità. L’idea che un po’ di violenza di piazza possa servire da innesco a chissà quale presa di coscienza collettiva, così come quella che l’insorgenza di piazza sia l’unica forma possibile di espressione collettiva per le esperienze esistenti, sono semplicemente infantili. Il conflitto nelle piazze non può essere la rappresentazione esemplare di una conflittualità che si considera altrimenti assente o insufficiente. In questo caso saremmo di fronte all’espropriazione della possibilità di azione di massa e anche all’impossibilità pratica di costruire forme di conflittualità condivise.
D’altra parte anche sostenere che chi rompe tutto lo fa per una spontanea e incontrollabile rabbia, senza la pretesa di rappresentare nessuno, non si accorge che una simile individualizzazione dei comportamenti finisce per essere il rovescio, l’opposto simmetrico, dei comportamenti assolutamente individuali che il neoliberalismo pretende da ognuno di noi. Non è forse il caso di rompere con la condizione quotidiana di isolamento, invece di rappresentarla fedelmente anche durante le manifestazioni collettive? Ma già ragionare a partire da questa spontanea individualizzazione non coglie tutta la portata del problema. Qualche mese fa, prima dell’assedio e dei blocchi di Francoforte, è uscito un documento che annunciava il fallimento del movimento no-global e l’inutilità di ogni tentativo di costruire reti organizzative transnazionali, declassate direttamente a «reti solidali», così come chiunque provava a organizzarle era bollato come burocrate e con il marchio d’infamia di voler essere «ceto politico di movimento».
Ecco, secondo noi la differenza sta esattamente qui. Ed è a partire da questa differenza che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità politiche. Qui non si tratta di dividere i buoni dai cattivi e nemmeno gli arrabbiati dai pavidi. Qui si tratta di evidenziare, e in caso discutere, una specifica differenza di prospettiva politica. Qui si tratta di dire chiaramente che c’è chi pensa che sia necessario costruire quotidianamente connessioni dentro le lotte e le molteplici figure che in esse si esprimono, anziché replicare attivamente l’individualizzazione altrimenti imposta. Qui si tratta di stabilire collegamenti non tra la propria singolare quotidianità e il riot di un giorno, ma tra le molteplici e disomogenee singolarità che ogni giorno sono costrette dentro e contro il lavoro precario operaio e migrante. Qui si tratta di ribadire che tutto questo non è possibile su un piano locale e che la dimensione europea è il suo minimo piano di sviluppo. Qui non si tratta dell’espressione immediata di un’identità sovversiva, ma dell’assenza di ogni identità consolidata e della difficoltà quotidiana per trovare forme collettive di espressione. Qui non si tratta di far esprimere qualcosa che già c’è, ma di costruire lo spazio per qualcosa che ancora non c’è, proprio perché ancora non riesce a trovare una forma collettiva di espressione. Noi pensiamo che questo sforzo verso il collettivo sia il primo punto all’ordine del giorno. Altri non lo pensano e si comportano di conseguenza. Sarebbe perciò il caso di smetterla con la facile critica dei giornali, con gli opinionisti occasionali che sono bravi quando ti danno ragione e canaglie quando ti danno torto, con il gioco incrociato delle citazioni. Sarebbe il caso di parlare seriamente delle prospettive politiche che si vogliono perseguire. Tutto il resto rischia di essere poco interessante e persino indifferente per i moltissimi che condividono la nostra condizione.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione