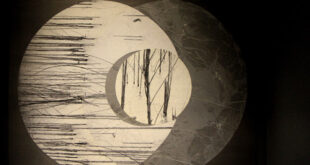di MATTEO CAVALLERI
 Gli anniversari a cifra tonda portano spesso con sé il rischio di nevrosi commemorative, i cui sintomi consistono nel manifestare con estrema intensità quelle tendenze celebrative museificanti e agiografiche – comunque sempre presenti – che comportano la corrosione del significato stesso che le date costudiscono. Questo settantesimo della Liberazione sembra non sfuggire alla diagnosi. Ecco perché può risultare politicamente decisivo pensare il 25 aprile dalla prospettiva dell’8 settembre 1943. Un gesto di strabismo teso a cogliere – nel tempo difficile, denso e sospeso del decidersi per la Resistenza – il portato di verità che ha innervato l’intera esperienza della lotta al nazi-fascismo. Che ha espresso una pratica d’azione e pensiero in grado di reggere il peso della scelta e della parte. E che ancora ci interpella.
Gli anniversari a cifra tonda portano spesso con sé il rischio di nevrosi commemorative, i cui sintomi consistono nel manifestare con estrema intensità quelle tendenze celebrative museificanti e agiografiche – comunque sempre presenti – che comportano la corrosione del significato stesso che le date costudiscono. Questo settantesimo della Liberazione sembra non sfuggire alla diagnosi. Ecco perché può risultare politicamente decisivo pensare il 25 aprile dalla prospettiva dell’8 settembre 1943. Un gesto di strabismo teso a cogliere – nel tempo difficile, denso e sospeso del decidersi per la Resistenza – il portato di verità che ha innervato l’intera esperienza della lotta al nazi-fascismo. Che ha espresso una pratica d’azione e pensiero in grado di reggere il peso della scelta e della parte. E che ancora ci interpella.
Licenziando, nell’aprile del 1945, la prefazione al suo Un uomo, un partigiano lo storico – e poi militante politico – Roberto Battaglia si presenta al lettore con un rivelatore cameo biografico: «l’8 settembre 1943 ero un tranquillo studioso di storia dell’arte, chiuso in un cerchio limitato di interessi e di amicizie; l’anno dopo, l’8 agosto, ebbi il comando d’una divisione partigiana che ha dato più di un fastidio al tedesco». Una tale metamorfosi, vissuta sia sul piano esistenziale sia su quello politico e sociale – «un cambiamento della mia apparenza sociale, se non di me stesso», chiosa Battaglia – è sintomo evolutivo della frattura apertasi con l’8 settembre 1943, nel suo indistricabile intreccio di sospensione, di attesa interrogativa, ma anche di accelerazione verso una necessaria e lucida presa di coscienza sul presente. Italo Calvino – in La stessa cosa del sangue – comprime questi sentimenti in una vivida immagine temporale: «il ritmo delle cose era cambiato, troppo lenti i sensi, troppo lenti i pensieri. Da un momento all’altro, cambiato».
L’8 settembre, infatti, si presenta come l’irruzione di un «bosco di domande», di un evento che disarticola completamente sia la logica della guerra sia la vita stessa di milioni di cittadini, fossero questi militari o civili. In un editoriale apparso nell’autunno del 1945 su “Giustizia e libertà”, ricordando l’armistizio di due anni prima, Carlo Dionisotti definisce «la data» come un punto di abissale riferimento nella storia d’Italia, un giorno rispetto al quale c’è un prima e un dopo: «un nodo che non si sfila. Ed è acquisita come forse nessun’altra in passato, perché dentro e al di là di un evento comune, milioni di italiani hanno, in proprio, [legato] a quel giorno una pausa e una svolta nella loro singola vita». L’8 settembre, a differenza del gioco «elegante» e squisitamente politico del 25 luglio, erompe nella situazione storica italiana come una «rivoluzione angosciosa», come uno strappo aperto tra «perdite enormi ma forse inevitabili». L’accadere oggettivo della storia squarcia la dimensione soggettiva dell’esistenza, in una tensione contrassegnata da un ossimorico intreccio di paralisi, di libertà e di invenzione, come rammenta il Chiodi di Il partigiano Johnny: «vedi, l’angoscia è la categoria del possibile. Quindi è infuturamento, si compone di miriadi di possibilità, di aperture sul futuro. Da una parte l’angoscia, è vero, ti ributta sul tuo essere, e te ne viene amarezza, ma d’altra parte essa è il necessario sprung, cioè salto verso il futuro…».
È in questa condizione che il futuro partigiano esperisce il disordine introdotto dall’armistizio, tanto la difficoltà e il dolore morale a esso connessi – «mi spaventano quelli che dicono di avere sempre capito tutto, che continuano a capire tutto. Capire l’8 settembre non era facile!» sottolinea con forza Nuto Revelli in La guerra dei poveri –, quanto le potenzialità di un nuovo inizio, la matrice generativa permessa dalla corrosione del vacuo e violento ordine fascista.
Ma cosa c’è da capire l’8 settembre? Cosa c’è da scegliere? Il momento storico non convoca a una scelta per «un modo qualsiasi di esistere», ma chiede di scegliere o meno per l’esistenza stessa, chiede di ristabilire le condizioni di possibilità perché l’esistenza stessa dell’uomo possa essere effettiva, «l’esistenza insomma dell’uomo nell’esercizio libero del suo pensiero e del suo lavoro», scrive sempre Dionisotti in un frammento del 1944. E individua nella lotta resistenziale una tensione produttiva, una pratica ri-generativa dell’umano messa in atto dall’accadere stesso della storia:
Questa, se mai altra, è la guerra onde può attendersi l’uomo, secondo l’antico detto, fabbro della sua fortuna, l’individuo esperto di tanto male e ansioso finalmente del bene, l’individuo sì, che, superstite dell’eccidio, solo con la sua libera vita, fatta giustizia del nemico, riconosce intorno a sé negli altri superstiti i compagni e con quelli imprende la via: questa, se mai altra, la guerra onde può attendersi non una, ma la rivoluzione dell’antica Europa.
Cosa significa che l’uomo, in questa guerra, «può attendersi»? Quale dinamica ontologica è sottesa da questa attesa? Sembra infatti sussistere, accanto e intrecciata a uno sforzo soggettivo e alla nominazione di un’individualità agente – l’individuo «fabbro della sua fortuna», «esperto» e in grado di riconoscere i propri compagni – una processualità storico-oggettiva. Occorre, in altri termini, che sia successo qualcosa di supplementare rispetto alla situazione presente perché la singolarità dell’individuo vada a comporre un nuovo soggetto. La sensibilità estetica di Jean Starobinski, in un saggio del 1943, coglie questo «qualcosa in più» – questo qualcosa che accade contraddicendo le regole dello stato di cose presente, direbbe Alain Badiou – come una distorsione delle dinamiche oggettive e autolegittimantesi caratteristiche del tempo ordinario e, parimenti a Dionisotti, istituisce un rapporto di necessità tra la realizzazione effettuale dell’esistenza soggettiva e la peculiarità della circostanza storica: «il tempo è fuori dai cardini, bisogna raggiungere l’esistenza». Starobinski nomina questa circostanza come un evento, come un qualcosa che non c’era e che, nel momento in cui avviene, comporta una concatenazione di mutamenti. La situazione presente si apre al possibile e al nuovo, seppur nella drammaticità e, conseguentemente, l’individuo è chiamato proprio da tale supplemento d’essere a decidersi per una nuova e impensata modalità d’esistere. L’8 settembre è quindi la porta d’accesso nella situazione storica per quell’evento che possiamo chiamare Resistenza. Come si configuri la geometria di accadimento dell’evento e quale sia l’impatto che questo ha sulla situazione storica costituiscono i temi cardine della riflessione ontologica di Alain Badiou. Il filosofo francese definisce l’evento come un «cominciamento radicale», come la genesi di una procedura di verità resa possibile da una modificazione dirompente di «una molteplicità data». Tale modificazione è mossa dall’introduzione di «una nominazione singolare, l’entrata in gioco di un significante in più. E sono gli effetti nella situazione di questa entrata in gioco di un “nome in più” che instaurano una procedura generica e determinano l’evenienza di una verità della situazione». Con l’8 settembre, quindi, si introduce nella situazione risultante dalla caduta del fascismo un significante in più: quello della scelta. È la possibilità di scegliere, intesa primariamente come scegliere di voler scegliere, a costituire l’elemento supplementare, l’innominabile all’interno del paradigma fascista. La scelta per la Resistenza si configura quindi come una fedeltà all’evento Resistenza, come un continuo riabitare quella possibilità di scelta originaria. Come un trovare forme nuove, pensieri e azioni, per mezzo delle quali rapportarsi alla situazione storica sempre dalla prospettiva aperta dalla verità dell’evento (proprio come, dopo quell’evento che possiamo chiamare rivoluzione copernicana, la fedeltà alla sua verità consiste nel leggere sempre la situazione dalla prospettiva dell’eliocentrismo). Le tracce di una tale fedeltà determinano la procedura di verità esplosa in Italia nel settembre 1943. Sono gesti che nella lacerante immanenza della determinatezza storica producono rotture e ne reinventano ogni volta la sostanza: sono la scelta per la montagna, la clandestinità, la lotta armata, i sabotaggi, il gappismo, le attività di disarmo, le staffette, gli atti terroristici, l’appoggio ai partigiani… Sino alla decisione di rivivere questa scelta, trasfigurandola, nella narrazione di tali esperienze di lotta. Come coglie puntualmente Gabriele Pedullà, tutte queste scelte sono mosse dalla medesima pulsione di verità.
Se l’evento Resistenza inaugura, tramite il nome in più della scelta, la procedura di verità nella situazione storica, qual è il ruolo del soggetto e, soprattutto, chi è il soggetto? Badiou risponderebbe che il soggetto è il «supporto» che sorregge l’attuarsi di un processo di fedeltà, che permette il realizzarsi degli effetti di una verità ma che, allo stesso tempo, è prodotto da questo stesso processo. L’essere partigiano non preesiste quindi all’esperienza della scelta introdotta dall’evento, alla sua possibilità, ma vi consegue. La presenza di numerosi antifascisti in fase pre-resistenziale fu fondamentale (e che aderirono all’antifascismo per svariati motivi: politici, etici, religiosi, civili…), ma l’8 settembre accadde qualcosa che impose una sfasatura nelle loro biografie e nella loro stessa tessitura antropologica. Mutamento che Pietro Chiodi, in Banditi, esprime con estrema lucidità:
Perché mi sono impegnato in questa lotta? Perché sono qui quando tanti più sani e forti di me vivono tranquilli sfruttando la situazione in ogni modo? Ripenso alla mia vita di studio, al mio lavoro su Heidegger interrotto. Perché ho abbandonato tutto questo? Mi ricordo con precisione: una strada piena di sangue e un carro con quattro cadaveri vicino al Mussotto. Il cantoniere che dice: – È meglio morire che sopportare questo –. Sì è allora che ho deciso di gettarmi allo sbaraglio. Avevo sempre odiato il fascismo ma da quel momento avevo sentito che non avrei più potuto vivere in un mondo che accettava qualcosa di simile, fra gente che non insorgeva pazza di furore, contro queste belve. Una strana pace mi invade l’animo a questo pensiero. Ripeto dentro di me: «Non potevo vivere accettando qualcosa di simile. Non sarei più stato degno di vivere».
Senza marcare la differenza introdotta dalla cesura dell’armistizio, soprattutto, non si potrebbe spiegare l’adesione alla lotta, nella sua pluriforme fenomenologia, di migliaia di giovani scevri di qualsiasi formazione culturale e politica e, soprattutto, perfettamente fascistizzati. I singoli individui partecipano alla composizione del soggetto «partigiano» nel momento in cui la scelta li rompe, nella loro dimensione normalizzata e nel loro incedere nell’ordine della situazione che precede l’evento e li coglie come nuovi soggetti, come supporti di un percorso di fedeltà alla scelta stessa. Fedeltà che deve essere puntualmente confermata, che deve essere continua, personale – ma anche dolorosa e difficile – adesione. Che non si può cristallizzare in un giuramento, in quanto significherebbe sterilizzare le potenzialità mosse dall’evento in quella che Jean Paul Sartre definirebbe «inerte determinazione del futuro». Continuare a scegliere significa rinnovare quotidianamente, all’interno della relazione dialettica di libertà e necessità, l’intimo gesto critico, l’originaria frattura avvenuta nella coscienza individuale.
Scrive Camillo De Piaz:
La Resistenza […] nelle nostre condizioni non si poteva non fare. Erano condizioni in definitiva obbligate, il che, almeno per chi ha voglia e capacità di intendere, anziché sminuirne la grandezza la fa risaltare maggiormente. Che cosa vi può essere di più grande, di più storicamente ed esistenzialmente pregnante, di una necessità che assume la dimensione di una scelta? La cosa appare contraddittoria, ma ci sono dei momenti in cui si danno di queste occasioni che non si possono inventare.
È quindi la peculiarità oggettiva del momento – che non si può totalmente inventare –, il suo presentarsi come una riapertura della storia mossa da un evento, a far sì che il soggetto resistente compaia in quanto tale e venga alla presenza nella sua veste etica e politica. Venire alla presenza che è animato da uno sforzo soggettivo atto a spezzare «l’inganno di una soggettività costitutiva» (Theodor Wiesengrund Adorno) e caratterizzato da una continua mutua mediazione tra soggetto e oggetto. Senza la coscienza di una tale processualità – nella quale matura, ad esempio, la gestione critica e responsabile della violenza e la condanna della sua fascinazione – il partigiano resterebbe invischiato in quella che Simone Weil definisce la «dura necessità», ovvero in ciò che lo schiaccia come bruta forza. Cogliersi continuamente rotto e colto dal e nel percorso di fedeltà all’evento Resistenza permette di assumere la necessità a un livello più alto, mutandone il valore, ma senza mutarne la natura. La necessità rimane necessità, anche se mutata di grado; Weil è estremamente chiara su questo. Ma, parimenti, sottolinea di questa medesima natura la forza liberatrice: «solo la necessità universale libera da essa», ovvero: solo una necessità compresa come la necessità che scaturisce da un evento e che mi costituisce in quanto soggetto mi libera dalla dura necessità. Solo la coscienza di questo passaggio, la coscienza di essere immerso in una necessità che va cambiata di segno, permette al partigiano di non cedere al fascista che potenzialmente lo anima: «Solo quando sarà necessario e mai alla presenza di estranei si procederà a un interrogatorio energico, altrimenti niente. Se è accertata la responsabilità del catturato si passa per le armi, ma mai maltrattamenti. Saremmo ancora fascisti», intima un dispaccio partigiano diffuso nei tremendi giorni precedenti alla liberazione. In questo «ancora» si riassume l’essenza dell’antropologia partigiana: il partigiano, rispetto al fascista, non è né un “oltre-uomo” né un “altro-uomo” definibile a priori. Piuttosto, il resistente agisce da altro uomo. L’antropologia resistenziale si plasma e si educa, in ogni singola scelta, nella medesima sostanza umana che il partigiano condivide con il fascista. Il resistente smette di essere fascista – non nasce diverso dal fascista – quando sceglie di scegliere di non essere più tale. Qui sta l’elemento pratico, politico, della sua antropologia. E su questo si fonda la differenza – «un sacramento, un segno indelebile che non si cancella mai più», sancisce Luigi Meneghello – tra il partigiano e il milite della brigata nera. Una differenza che si muove nel dettaglio, quasi impercettibile, ma che è radicale e assoluta:
Ferriera mugola nella barba: – Quindi, lo spirito dei nostri… e quello della brigata nera… la stessa cosa? … – La stessa cosa, intendi cosa voglio dire, la stessa cosa… – Kim s’è fermato e indica con un dito come se tenesse il segno leggendo; – la stessa cosa ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qui si risolve qualcosa, là ci si ribadisce la catena.
Qui, continua Calvino in Il sentiero dei nidi di ragno, ogni gesto, anche la violenza, si inscrive nel movimento di verità che anima la storia: quello della liberazione e dell’emancipazione; ogni gesto non è mai fine a se stesso, non è mai tassello di un’epopea nichilista. La violenza, proprio come messo in evidenza sia da Hannah Arendt sia da Simone Weil relativamente alla guerra di Troia, inaugura – in una derivazione per contrasto – la politica. E quando la politica coglie il senso della storia, la verità che la innerva, non si lascia – seppur nel travaglio morale di una minoranza che si è messa autonomamente fuori legge e ha assunto il peso della responsabilità della violenza e del dolore che ne proviene – saturare dalla violenza da cui ha avuto origine e diviene politica di liberazione. Appunto, muta di segno la necessità che l’ha inaugurata. E così conclude Kim:
C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. Da noi, niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pure uguale al loro, m’intendi? Uguale al loro, va perduto, tutto servirà se non a liberare noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L’altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori, perduti e inutili anche se vincessero, perché non fanno storia, non servono a liberare ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell’odio, finché dopo altri venti o cento o mille anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso odio anonimo negli occhi e pur sempre, forse senza saperlo, noi per redimercene, loro per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta; il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali.
È il saper riconoscere questo aprirsi della storia ciò che contraddistingue l’insorgere del soggetto resistente, ciò che anima la sua disciplina. Ed è forse questo gesto, che è in primis un gesto di pensiero, che ancora oggi ci interpella. Un gesto che è potenzialmente accomunante, ma che non necessita di un appartenenza comune. Un evento accade, ma va colto, e va colto nel pensiero inteso come rischio del rischio, come rischio per la scelta. Come rischio per il possibile. Poi, perché questo possibile si instauri, cresca, diventi eticità, per dirla con Hegel, c’è bisogno di un soggetto in grado di legare la verità introdotta dall’evento con le determinazioni della storia. C’è bisogno di inventarsi una forma di organizzazione.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione