di PAOLA RUDAN
Pubblichiamo la versione integrale della recensione apparsa su «il Manifesto» del 14 gennaio 2015
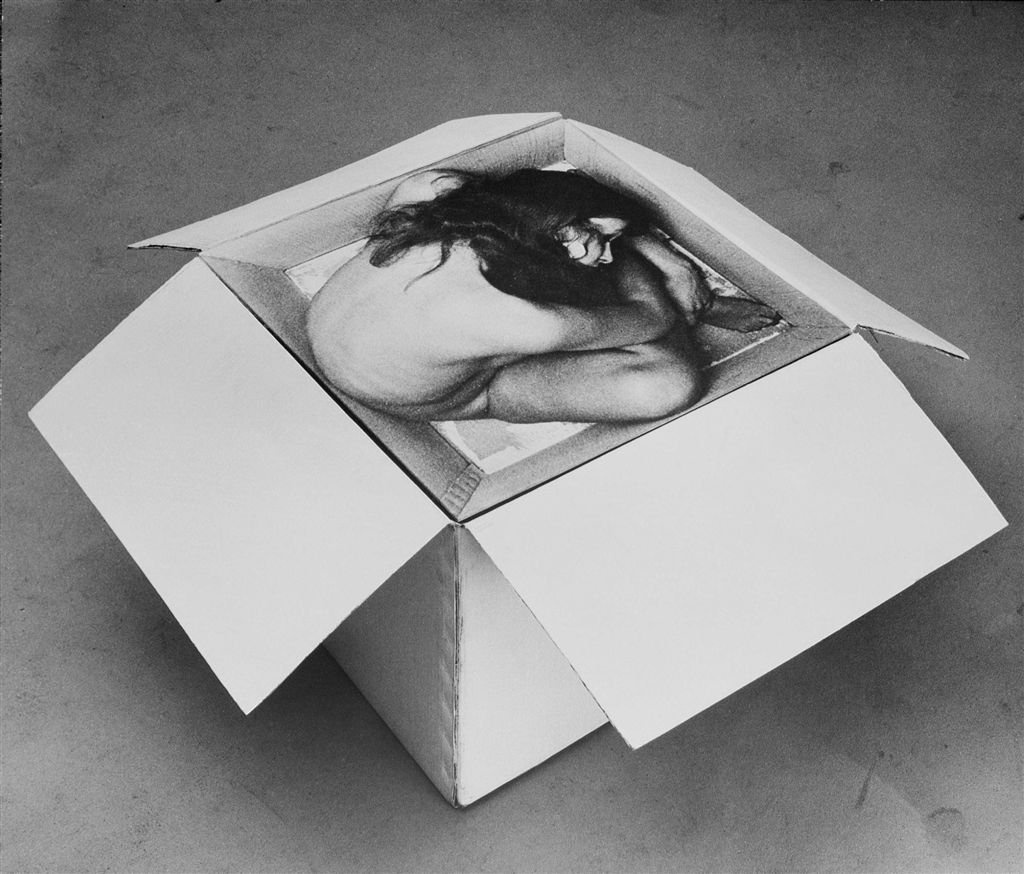 Persino i più convinti detrattori della filosofia della storia hanno rischiato di vedere nel passaggio dal fordismo al post-fordismo un momento progressivo, segnato dalla fine dell’uguaglianza coatta del regime di fabbrica sotto la spinta di un’istanza di liberazione dal lavoro. Ora che questo passaggio è ormai avvenuto, ci si può guardare indietro non per il piacere di dipingere grigio su grigio la nuova realtà, ma per la necessità di comprendere che cosa sia effettivamente cambiato nella vita comunque messa al lavoro. La libertà del regime neoliberale si rivela infatti sempre di più come la matrice di una precarizzazione globale e senza confini. Nel suo Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista (ombre corte, 284 pp., 24 €) – che raccoglie saggi pubblicati tra il 1985 e il 2010 – Nancy Fraser ripercorre questo passaggio attraverso le lenti privilegiate del femminismo, la cui fortuna consiste nel fatto di aver contribuito a determinarlo e nell’essere, perciò, un punto di vista parziale in grado di gettare luce su processi di portata globale. Il discorso femminista è globale perché l’ineliminabile parzialità del suo sguardo riemerge comunque all’interno di qualsiasi scenario. Con la sua critica al «capitalismo androcentrico e organizzato dallo Stato», però, il femminismo (in particolare quello statunitense di seconda generazione, su cui Fraser si concentra) avrebbe inavvertitamente ceduto alle lusinghe del «nuovo spirito del capitalismo». In sintonia con l’anelito «post-socialista» degli anni ’80, esso avrebbe rinunciato alla politica dell’uguaglianza in favore di una politica della differenza, accordando priorità alla critica dei «modelli culturali istituzionalizzati» rispetto a quella dell’economia politica, alla rivendicazione del riconoscimento piuttosto che della redistribuzione. «Reclamare» il femminismo, per Fraser, significa allora riconoscere che esso deve liberarsi dalla sua liaison dangereuse con il neoliberalismo per poter riaffermare il suo potenziale di «emancipazione». La ricostruzione storica è ciò che permette di interrogarsi sulle possibilità di una trasformazione radicale anche dopo – e nonostante – la fine della storia.
Persino i più convinti detrattori della filosofia della storia hanno rischiato di vedere nel passaggio dal fordismo al post-fordismo un momento progressivo, segnato dalla fine dell’uguaglianza coatta del regime di fabbrica sotto la spinta di un’istanza di liberazione dal lavoro. Ora che questo passaggio è ormai avvenuto, ci si può guardare indietro non per il piacere di dipingere grigio su grigio la nuova realtà, ma per la necessità di comprendere che cosa sia effettivamente cambiato nella vita comunque messa al lavoro. La libertà del regime neoliberale si rivela infatti sempre di più come la matrice di una precarizzazione globale e senza confini. Nel suo Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista (ombre corte, 284 pp., 24 €) – che raccoglie saggi pubblicati tra il 1985 e il 2010 – Nancy Fraser ripercorre questo passaggio attraverso le lenti privilegiate del femminismo, la cui fortuna consiste nel fatto di aver contribuito a determinarlo e nell’essere, perciò, un punto di vista parziale in grado di gettare luce su processi di portata globale. Il discorso femminista è globale perché l’ineliminabile parzialità del suo sguardo riemerge comunque all’interno di qualsiasi scenario. Con la sua critica al «capitalismo androcentrico e organizzato dallo Stato», però, il femminismo (in particolare quello statunitense di seconda generazione, su cui Fraser si concentra) avrebbe inavvertitamente ceduto alle lusinghe del «nuovo spirito del capitalismo». In sintonia con l’anelito «post-socialista» degli anni ’80, esso avrebbe rinunciato alla politica dell’uguaglianza in favore di una politica della differenza, accordando priorità alla critica dei «modelli culturali istituzionalizzati» rispetto a quella dell’economia politica, alla rivendicazione del riconoscimento piuttosto che della redistribuzione. «Reclamare» il femminismo, per Fraser, significa allora riconoscere che esso deve liberarsi dalla sua liaison dangereuse con il neoliberalismo per poter riaffermare il suo potenziale di «emancipazione». La ricostruzione storica è ciò che permette di interrogarsi sulle possibilità di una trasformazione radicale anche dopo – e nonostante – la fine della storia.
L’insistenza di Fraser sul problema dell’emancipazione va letta come un preciso tentativo di rivalutare la «politica dell’uguaglianza» alla luce di una comprensione storica e non dogmatica della sua distanza e opposizione con la «politica della differenza». Non si tratta quindi di scegliere un’opzione invece che l’altra e nemmeno di descrivere comodamente una polarizzazione irresolubile. Fraser sceglie piuttosto di indagare l’uguaglianza come problema irrisolto di un’irrinunciabile differenza. Come emerge chiaramente quando confronta gli effetti di possibili politiche di «welfare post-industriale», il problema di Fraser è di sfuggire tanto alla trappola dell’uguaglianza come «uguale trattamento», che fa del modello maschile una norma, quanto a quella del riconoscimento della differenza, che rischia di assumere una nozione essenzialistica della femminilità, che ha il suo correlato neoliberale in uno sfruttamento specifico ma non per questo meno feroce. Se i termini del problema non sono nuovi, meritano attenzione le conseguenze che Fraser ne trae. Si tratterebbe di articolare un approccio «bidimensionale» alla giustizia di genere che consideri le sue implicazioni sia dal punto di vista della classe sia da quello dello status. La subordinazione delle donne, infatti, è radicata nella struttura economica della società, secondo il criterio della divisione sessuale del lavoro, ma allo stesso tempo è anche il risultato di «modelli di valore androcentrici istituzionalizzati», che investono il diritto, le politiche pubbliche, la cultura popolare. In questa prospettiva bidimensionale, l’idea di emancipazione sostenuta da Fraser risulta di difficile definizione e non coincide con uno schieramento di principio in favore dell’uguaglianza. Piuttosto, il potenziale emancipativo tanto dell’uguaglianza quanto della differenza può essere misurato solo storicamente, rispetto alla loro effettiva capacità di modificare rapporti di subordinazione determinati.
Lo sguardo bidimensionale di Fraser articola così una sorta di ‘storia e teoria politica degli effetti’, che mira a indagare come le conseguenze politiche di una rivendicazione mutano in relazione al contesto, rideterminando le condizioni della soggettivazione. Nel contesto del capitalismo organizzato dallo Stato del secondo dopoguerra, l’effetto della rivendicazione da parte delle donne dell’uguaglianza come redistribuzione non è stato semplicemente la loro inclusione nella sfera pubblica maschile e nel mondo del lavoro, ma avrebbe posto in questione la struttura di differenziazione e subordinazione sessuale – il modello androcentrico del «salario familiare» – su cui si fondava quella specifica forma di organizzazione capitalistica della società. Tuttavia, mentre l’ideale di emancipazione attraverso il lavoro ha spinto le donne a uscire dal ruolo tradizionalmente ascritto al loro sesso, nel contesto neoliberale la crisi della tradizionale distinzione tra uomo-breadwinner e donna-housewife ha avuto l’effetto di «intensificare la valorizzazione capitalistica del lavoro salariato» di cui le donne sono sempre più protagoniste su scala globale. Contemporaneamente, la critica allo statalismo caratteristico dei regimi di welfare e alla natura oppressiva dello Stato sociale è stata incorporata nel processo di riduzione della spesa pubblica e di privatizzazione dei servizi spianando la strada al neoliberalismo. Sono solo due esempi di quelle che Fraser definisce «astuzie della storia», con un richiamo all’hegeliana astuzia della ragione che non è evidentemente casuale, ma segnala la comprensione di un movimento globale capace di nutrirsi delle contraddizioni che lo minacciano e di superarle incorporandole.
 Quest’osservazione permette di sottolineare la peculiare combinazione di «marxismo e svolta culturale» rivendicata da Fraser, che corre parallela all’esigenza di intrecciare classe e status nella teoria femminista della giustizia. Fraser abbraccia il fulcro della «svolta culturale» – vale a dire l’idea che i discorsi costituiscano l’identità sociale delle persone e i modi di soggettivazione – senza però ignorare la lotta politica necessaria a mutare la distribuzione del potere discorsivo né la relazione tra gli slittamenti semantici e i cambiamenti «istituzionali e socio-strutturali». Le conseguenze epistemologiche di questa combinazione – rese evidenti dalla critica alle teorie di Michel Foucault e Judith Butler – sono di per sé degne di nota. Fraser si serve infatti a piene mani dell’approccio genealogico foucaultiano, in particolare nella sua analisi dei discorsi sui bisogni e sulla dipendenza, ma a Foucault – impegnato a sviluppare una teoria del potere senza soggetto – contesta l’incapacità di cogliere il conflitto tra discorsi in competizione, con la conseguenza di «trattare gli esperti del servizio sociale come i soli soggetti storici». Nella prospettiva di Fraser, la comprensione degli ‘effetti discorsivi’ è inseparabile dal riconoscimento di asimmetrie fondamentali che attraversano la società e per questa ragione pratica una ‘critica dell’ideologia’ che la spinge a domandarsi come l’«egemonia socio-culturale dei gruppi dominanti» sia conseguita e contestata. D’altra parte, l’idea che vi sia una dimensione «socio-strutturale» che non è riducibile a un effetto discorsivo diventa essenziale per non trattare le differenze che attraversano la società in termini di perfetta equivalenza. Così, ad esempio, per Fraser riconoscere le discriminazioni di status subite da gay e lesbiche e gli effetti economici e materiali dei modelli culturali che legittimano quelle discriminazioni non significa credere, come fa Butler, che l’eterosessismo sia una parte fondamentale della struttura economica. È infatti empiricamente evidente che il capitalismo contemporaneo ha imparato a fare a meno della famiglia nucleare eterosessuale, mentre le discriminazioni subite da gay e lesbiche non fanno di loro «una classe di lavoratori servili». Non tutte le differenze, quindi, sono messe a valore allo stesso modo dal neoliberalismo, né tutti i modelli culturali hanno gli stessi effetti da un punto di vista di classe. Il femminismo dovrebbe essere in grado di affrontare la svalutazione culturale del lavoro di cura che continua a produrre effetti anche al di fuori del tradizionale modello del salario familiare, condannando le donne a entrare nel mercato del lavoro in una condizione svantaggiata (e differenziata anche secondo la linea del colore) e rendendole, come lavoratrici salariate, la «pietra angolare» del nuovo regime di accumulazione neoliberale.
Quest’osservazione permette di sottolineare la peculiare combinazione di «marxismo e svolta culturale» rivendicata da Fraser, che corre parallela all’esigenza di intrecciare classe e status nella teoria femminista della giustizia. Fraser abbraccia il fulcro della «svolta culturale» – vale a dire l’idea che i discorsi costituiscano l’identità sociale delle persone e i modi di soggettivazione – senza però ignorare la lotta politica necessaria a mutare la distribuzione del potere discorsivo né la relazione tra gli slittamenti semantici e i cambiamenti «istituzionali e socio-strutturali». Le conseguenze epistemologiche di questa combinazione – rese evidenti dalla critica alle teorie di Michel Foucault e Judith Butler – sono di per sé degne di nota. Fraser si serve infatti a piene mani dell’approccio genealogico foucaultiano, in particolare nella sua analisi dei discorsi sui bisogni e sulla dipendenza, ma a Foucault – impegnato a sviluppare una teoria del potere senza soggetto – contesta l’incapacità di cogliere il conflitto tra discorsi in competizione, con la conseguenza di «trattare gli esperti del servizio sociale come i soli soggetti storici». Nella prospettiva di Fraser, la comprensione degli ‘effetti discorsivi’ è inseparabile dal riconoscimento di asimmetrie fondamentali che attraversano la società e per questa ragione pratica una ‘critica dell’ideologia’ che la spinge a domandarsi come l’«egemonia socio-culturale dei gruppi dominanti» sia conseguita e contestata. D’altra parte, l’idea che vi sia una dimensione «socio-strutturale» che non è riducibile a un effetto discorsivo diventa essenziale per non trattare le differenze che attraversano la società in termini di perfetta equivalenza. Così, ad esempio, per Fraser riconoscere le discriminazioni di status subite da gay e lesbiche e gli effetti economici e materiali dei modelli culturali che legittimano quelle discriminazioni non significa credere, come fa Butler, che l’eterosessismo sia una parte fondamentale della struttura economica. È infatti empiricamente evidente che il capitalismo contemporaneo ha imparato a fare a meno della famiglia nucleare eterosessuale, mentre le discriminazioni subite da gay e lesbiche non fanno di loro «una classe di lavoratori servili». Non tutte le differenze, quindi, sono messe a valore allo stesso modo dal neoliberalismo, né tutti i modelli culturali hanno gli stessi effetti da un punto di vista di classe. Il femminismo dovrebbe essere in grado di affrontare la svalutazione culturale del lavoro di cura che continua a produrre effetti anche al di fuori del tradizionale modello del salario familiare, condannando le donne a entrare nel mercato del lavoro in una condizione svantaggiata (e differenziata anche secondo la linea del colore) e rendendole, come lavoratrici salariate, la «pietra angolare» del nuovo regime di accumulazione neoliberale.
Fraser non considera il neoliberalismo solo una ‘razionalità di governo’ capace di mettere a profitto le differenze, ma anche una nuova modalità di organizzazione della produzione e riproduzione sociale. Per lei, inoltre, l’imperativo neoliberale alla libertà come autoimprenditorialità ha effetti del tutto specifici quando a praticare quella libertà sono le donne, iscritte all’interno di un regime di divisione sessuale del lavoro ancora vigente, per quanto diverso da quello caratteristico del capitalismo «socialdemocratico» del secondo dopoguerra. La sua prospettiva emancipazionista è quindi diversa da quella che la critica femminista più radicale ha condannato, affidandone la gestione al ‘femminismo istituzionale’. L’uguaglianza che Fraser ritiene ancora necessario rivendicare non mira a neutralizzare la differenza sessuale. Piuttosto, proprio perché riconosce il peso che quella differenza ancora riveste nella produzione e riproduzione sociale globale, essa intende aggredire la struttura intrinsecamente androcentrica del capitalismo contemporaneo. Se l’uguaglianza deve investire il lavoro di cura facendone una questione pienamente sociale, deve allora esserci una trasformazione tanto della struttura della riproduzione quanto dei modelli culturali che la sostengono chiamando in causa, prima di tutto, gli uomini. Fraser utilizza così la pretesa dell’uguaglianza non come una memoria o una nostalgia, ma come una contraddizione che il regime neoliberale continua a riprodurre e che, proprio per questo, può essere radicalizzata e politicizzata in modo che le differenze non siano più catturate nel suo movimento astuto.
Tuttavia, le tre parole che Fraser rivendica nell’ottica dell’emancipazione – redistribuzione, riconoscimento e rappresentanza, termine con cui intende l’estensione non tanto dei diritti politici, quanto delle possibilità concrete di prendere parola – non riescono a esprimere tutta la forza di questa prospettiva. La via indicata, infatti, non sarebbe altro che quella di imporre ai mercati un nuovo controllo politico che permetta di governare gli interessi plurali dei gruppi sociali in modo che le conquiste di alcuni non si traducano in svantaggi per altri. Risulta perciò difficile capire in che modo si possano «smantellare i ruoli di genere e la loro codificazione culturale» se il capitalismo – di cui Fraser riconosce il carattere intrinsecamente androcentrico – non deve essere messo in discussione come tale, ma solo «domato» dalle istituzioni politiche, lasciando intatta la proprietà privata come criterio normativo. È altrettanto difficile capire come la proposta di Fraser si misuri con la dimensione compiutamente transnazionale del regime neoliberale. Una volta riconosciuto il declino dell’ordine keynesiano-westfaliano determinato dalla globalizzazione, Fraser non dice molto su quali siano le istituzioni che dovrebbero provvedere alla redistribuzione, al riconoscimento e alla codificazione istituzionale delle rivendicazioni di soggetti non più confinabili allo Stato territoriale. La mancata trattazione di questo problema rischia di tradursi in una nostalgia mai esplicitata per lo Stato, o nella semplice ammissione – ormai priva di originalità – della necessità di riconfigurare il rapporto tra diritti civili, politici e sociali di fronte all’obsolescenza del classico modello che puntava a costruire una relazione determinante tra cittadinanza e classe sociale.
Nonostante i limiti della sua proposta normativa, la riflessione di Fraser indica al femminismo contemporaneo questioni rilevanti, a partire dal riconoscimento che la sua fortuna consiste proprio nell’essere così radicalmente implicato nel passaggio dall’uguaglianza coatta del capitalismo organizzato dallo Stato alla libertà coatta del neoliberalismo. Mentre si discute attorno al nodo della libertà femminile e al modo in cui la sua pratica può sfuggire alla presa della «libertà neoliberale», parlando di uguaglianza Fraser pone il problema delle condizioni materiali della libertà. Come dimostrano ogni giorno le combattenti di Kobane, la rivendicazione di uguaglianza è ancora in grado di rovesciare la subordinazione che il patriarcalismo impone alle donne, in modi certamente specifici ma sempre globalmente rilevanti. Non si tratta allora di una disputa tra scuole o tradizioni di pensiero, ma della capacità del discorso politico femminista di essere significativo per le donne che attraverso di esso possono «costituirsi come soggetto collettivo». Anche se, con la sua critica al «simbolicismo» e al «determinismo ferreo» del lacanismo, Fraser trascura il problema della presa soggettiva degli ‘ordini discorsivi’, la sua riflessione mette il femminismo contemporaneo di fronte alla necessità di uscire dall’ambito rassicurante della discussione tra un’élite di esperte per diventare parte di una lotta controegemonica.
 In questa prospettiva va letta la sua scelta di storicizzare anziché decostruire. Storicizzare, per Fraser, significa porsi nella condizione di afferrare la realtà con le sue contraddizioni, di interrogarsi sul «doppio inquietante» che infesta il discorso politico delle donne quando diventa «indipendente dal movimento». La ‘storia degli effetti’ diventa allora essenziale per la teoria politica femminista: non solo per comprendere le ragioni del suo «cedimento» all’incorporazione neoliberale ma anche per prevenirla, riconoscendo ad esempio come la rivendicazione del reddito – quando i servizi sono venduti sul mercato – rischia di essere coerente con la mercificazione e la salarizzazione del lavoro domestico e di cura delle donne, anziché scardinare la divisione sessuale del lavoro su cui si regge. Eppure, proprio la dimensione storica diventa evanescente quando la proposta politica di Fraser non fa i conti fino in fondo con le trasformazioni dello Stato nel contesto globale. Pensare questa dimensione istituzionale rimane una questione all’ordine del giorno, che difficilmente può risolversi evocando una microfisica del welfare che incatena le donne alla riproduzione della sopravvivenza. Si tratta di una questione che Fraser non risolve, ma d’altra parte Fortune del femminismo non offre una teoria politica immediatamente spendibile e neppure slogan a buon mercato. Piuttosto, ci lascia il difficile compito di «diventare storicamente consapevoli», soprattutto «quando operiamo su un terreno che è popolato dal nostro inquietante doppio».
In questa prospettiva va letta la sua scelta di storicizzare anziché decostruire. Storicizzare, per Fraser, significa porsi nella condizione di afferrare la realtà con le sue contraddizioni, di interrogarsi sul «doppio inquietante» che infesta il discorso politico delle donne quando diventa «indipendente dal movimento». La ‘storia degli effetti’ diventa allora essenziale per la teoria politica femminista: non solo per comprendere le ragioni del suo «cedimento» all’incorporazione neoliberale ma anche per prevenirla, riconoscendo ad esempio come la rivendicazione del reddito – quando i servizi sono venduti sul mercato – rischia di essere coerente con la mercificazione e la salarizzazione del lavoro domestico e di cura delle donne, anziché scardinare la divisione sessuale del lavoro su cui si regge. Eppure, proprio la dimensione storica diventa evanescente quando la proposta politica di Fraser non fa i conti fino in fondo con le trasformazioni dello Stato nel contesto globale. Pensare questa dimensione istituzionale rimane una questione all’ordine del giorno, che difficilmente può risolversi evocando una microfisica del welfare che incatena le donne alla riproduzione della sopravvivenza. Si tratta di una questione che Fraser non risolve, ma d’altra parte Fortune del femminismo non offre una teoria politica immediatamente spendibile e neppure slogan a buon mercato. Piuttosto, ci lascia il difficile compito di «diventare storicamente consapevoli», soprattutto «quando operiamo su un terreno che è popolato dal nostro inquietante doppio».
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




