di LAVORO INSUBORDINATO
→ EN
→ Vedi anche «Il regime del salario» #1, #2, #3, #4, #5 #6
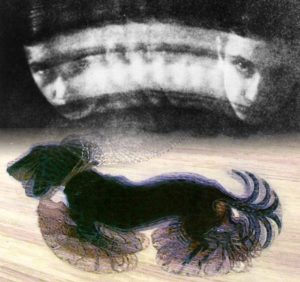 Dopo «Il regime del salario», Lavoro insubordinato inaugura un nuovo ciclo di interventi dedicati al «Governo della mobilità». In questo primo articolo si analizzano alcune tendenze delle politiche europee su lavoro, welfare e mobilità interna e le ragioni alla base della retorica del turismo sociale. Seguiranno indagini su specifiche situazioni di particolare rilevanza politica generale.
Dopo «Il regime del salario», Lavoro insubordinato inaugura un nuovo ciclo di interventi dedicati al «Governo della mobilità». In questo primo articolo si analizzano alcune tendenze delle politiche europee su lavoro, welfare e mobilità interna e le ragioni alla base della retorica del turismo sociale. Seguiranno indagini su specifiche situazioni di particolare rilevanza politica generale.
Recentemente il primo ministro britannico David Cameron ha affermato che «la libertà di movimento non è un diritto incondizionato». Detta in altri termini, la libertà di movimento può essere limitata. Le parole di Cameron esprimono chiaramente lo spirito dei tempi. In vari paesi europei, infatti, si assiste non solo a un’erosione dei diritti sociali parallela a una generalizzata precarizzazione del lavoro, ma anche – in particolare in paesi che a partire dalla crisi sono diventati mete di un crescente flusso migratorio di cittadini comunitari, come Regno unito e Germania – a una tendenziale restrizione delle possibilità di accesso ai diritti di welfare da parte dei migranti, interni ed esterni. Le misure nazionali adottate per restringere la libertà di movimento non contraddicono le dichiarazioni dell’Unione Europea, che considera la mobilità interna come un elemento positivo per omogeneizzare lo spazio dell’Unione in quanto permette di colmare gli scarti tra domanda e offerta di lavoro, i differenziali di «capitale umano» e dei tassi di disoccupazione. Si tratta piuttosto di due facce di uno stesso governo della mobilità che, mentre favorisce gli spostamenti funzionali al profitto e in linea con l’organizzazione regionale della produzione, contrasta la pretesa che milioni di migranti interni ed esterni hanno di non servire come forza lavoro usa e getta e di potere effettivamente scegliere dove andare e dove stare. Dopo che per anni, soli e inascoltati, i migranti extraeuropei hanno rivendicato la libertà di movimento, ora il problema comincia a investire anche i cittadini dell’Unione Europea. Anche chi da tempo sostiene che la condizione dei migranti avrebbe anticipato quella degli europei non ha però particolari motivi di soddisfazione. Lo spazio della libera circolazione di merci e persone è ormai solcato da gerarchie e differenze che ogni giorno colpiscono milioni di uomini e donne. La specifica condizione dei migranti extraeuropei non viene per questo cancellata, ma milioni di altri lavoratori iniziano a fare esperienza dell’inclusione parziale e temporanea che essi subiscono quotidianamente.
Durante la crisi, la mobilità interna all’UE è nel complesso cresciuta sebbene in maniera disomogenea, differenziandosi secondo gli squilibri salariali e il rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Rispetto agli anni prima della crisi, cioè dal 2004 al 2008, il flusso dai paesi del Sud dell’Europa è aumentato del 38%. I migranti dall’Europa centrale e dell’Est continuano però a costituire la quota maggiore di migranti interni (58%) mentre quelli dal Sud dell’Europa costituiscono il 18% del totale. Nel complesso, i migranti interni sono circa 13 milioni. Parallelamente all’aumento della mobilità interna, si è diffusa la retorica del turismo sociale, cioè l’idea secondo cui le migrazioni verso i paesi più ricchi dell’Unione siano motivate dall’intenzione di sfruttare il loro sistema di welfare: d’altronde si sa che con questa crisi nessuno ha il tempo e la possibilità di farsi una vacanza decente. Quindi perché non andare a farsi sfruttare più o meno regolarmente in qualche bar di Londra? Dicono che con i soldi dei sussidi di integrazione al reddito si fa la bella vita. Ma chi è che ottiene davvero il premio vacanze? La retorica del turismo del welfare, come viene anche chiamato, è smentita dai dati che mostrano che il tasso di occupazione dei migranti è superiore rispetto a quello dei residenti nel paese ospitante. Essa, tuttavia, si comprende solo se la si inserisce nel contesto della radicale scissione tra lavoro e diritti che si sta affermando nella cornice europea e che la crisi ha contribuito ad approfondire. Più che di un’erosione dei diritti legati al lavoro, dovuta alla diffusione generale della precarietà, si tratta di un’intermittenza dei diritti, che i migranti non europei vivono sulla loro pelle da decenni ben sapendo che il prezzo dei diritti è la coazione al lavoro. Sia che si tratti di benefici riconducibili al pagamento dei contributi, sia che si tratti di prestazione assistenziali i diritti tendono sempre più a essere presentati come privilegi che devono essere di volta in volta acquistati impiegando porzioni di reddito. I diritti incondizionati sono ormai molto pochi. Proprio per questo, su scala nazionale e continentale la regolamentazione dell’indennità di disoccupazione è una delle chiavi di volta del governo della mobilità. In una situazione in cui la disoccupazione non è una condizione eccezionale, ma strutturale dato il frequente passaggio da un lavoro a un altro, negare l’indennità di disoccupazione significa negare la possibilità materiale di godere del diritto alla libertà di movimento e promuovere una libertà completamente piegata alle esigenze del mercato del lavoro transnazionale.
In questo quadro si inseriscono i tentativi, in particolare di Belgio, Germania e Gran Bretagna (ma si ricordino anche le espulsioni dei rom dalla Francia nel 2010) di negare il godimento dei diritti di welfare ai migranti interni, tentativi che hanno aperto un dibattito sulla loro conformità alle direttive europee. Oltre agli accordi di Schengen, sono due le fonti principali di diritto che disciplinano il sistema interno della UE: la direttiva 2004/38 e il regolamento 883/2004. La direttiva afferma «la libertà di circolare e soggiornare liberamente all’interno degli Stati membri» e lega il godimento dei diritti di welfare alla presenza di un rapporto di lavoro, alla dimostrazione che si sta cercando un lavoro e che si è potenzialmente occupabili oppure alla dimostrazione di un reddito sufficiente. Sotto i tre mesi e sopra i cinque anni il soggiorno è senza condizioni. Questa direttiva, in altri termini, vincola il diritto di residenza dei cittadini UE alla disponibilità di risorse economiche sufficienti affinché i migranti interni non diventino un onere a carico dell’assistenza sociale del paese ospitante. Il regolamento dello stesso anno mira, invece, a promuovere la «totalizzazione» dei periodi di pagamento dei contributi, ovvero un calcolo globale dei contributi versati, in modo tale che vengano calcolati anche quelli pagati nel paese di provenienza per valutare il diritto o meno a determinate prestazioni di welfare. L’indennità di disoccupazione, ad esempio, dovrebbe essere elargita tenendo conto dei periodi di lavoro maturati nei due o più Stati membri in cui il singolo si è trovato a lavorare.
L’11 novembre scorso la Corte di Giustizia Europea, esprimendosi su un caso che ha avuto luogo in Germania, ha confermato che i benefici assistenziali devono essere negati a chi non sia alla ricerca di lavoro e non abbia un reddito sufficiente a mantenersi. Del resto a settembre la Commissione ha espresso in un report il proprio favore per l’introduzione in Germania di misure volte a limitare gli «abusi» nel godimento dei diritti di welfare nel paese di residenza. L’obiettivo è quello di «limitare gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei lavoratori, tra cui la scarsa consapevolezza delle norme UE da parte dei datori di lavoro sia pubblici sia privati e le difficoltà incontrate dai cittadini mobili nell’ottenere informazioni e assistenza negli Stati membri ospitanti». In quest’ottica, è ammessa la negazione del diritto di soggiorno a cittadini europei che abbiano mentito per ottenere i benefici nonché la possibilità di rifiutare i diritti di welfare ai figli di migranti che non risiedono in Germania. Nel report in questione, tuttavia, non ci si pronuncia sulla legge che proprio in questi giorni il parlamento tedesco sta votando in cui si prevede che, dopo sei mesi di disoccupazione, si venga inquadrati dal Job Center come «in cerca di lavoro» e si abbia l’obbligo di presentare una serie di prove per dimostrare l’effettiva ricerca di lavoro pena la riduzione o la sospensione dell’indennità. Come è evidente, il welfare diviene uno strumento per governare la libera circolazione in funzione della domanda di lavoro. Per questo, la sentenza della Corte di Giustizia, anche se non è di per sé innovativa e si attiene al quadro normativo esistente, è stata salutata come un’importante vittoria nella lotta contro il turismo sociale. L’interpretazione restrittiva delle norme sulla libertà di movimento è considerata uno strumento per abbattere il tasso nazionale di disoccupazione senza contrastare l’allargamento del bacino di lavoratori precari, part-time e sottopagati e l’obbligo di accettare ogni lavoro a ogni condizione. Se come abbiamo detto i dati smentiscono la retorica del turismo sociale, è invece evidente che il premio vacanze in questa fase se lo godono gli Stati, facendo un turismo sfrenato sulle prestazioni lavorative dei migranti, interni ed esterni, che pagano contributi che non vedranno mai, ma anche su quelle dei cittadini ai quali, mentre si riducono i salari all’osso, si può sempre raccontare la storia, ormai un best–seller, che i migranti rubano loro il lavoro.
Nel caso tedesco, il compito di verificare l’effettiva ricerca di lavoro da parte dei migranti comunitari è affidata ai job center, che tanto interessano al governo Renzi come modello per l’Agenzia Unica prevista nel Jobs Act. Si apre così un altro capitolo delle politiche relative al turismo sociale, che riguarda l’aumento dei controlli sui migranti per testare il loro grado di «occupabilità» e la disponibilità ad accettare le proposte di lavoro che vengono loro fatte. Coerentemente con un governo della mobilità orientato alle esigenze momentanee del mercato, gli enti di controllo hanno ampi margini di discrezione quando si tratta di definire una condizione di «inattività» o «inoccupabilità». Attenzione, il messaggio è questo: non è più tempo di andare in un altro paese per costruirsi una vita, o fare un’esperienza, o sfuggire al ricatto della precarietà: se ti sposti non avrai scampo, perché l’Europa promuove la libertà di sfruttamento. Se non sei disposto a farti sfruttare, puoi stare a casa tua. Questo è evidente nel caso belga. Il Belgio è stato richiamato nel 2013 da una nota della Commissione perché ha espulso negli ultimi anni più di 7000 cittadini comunitari secondo il principio che, se sei disoccupato da più di sei mesi e hai lavorato meno di dodici mesi, sei un inutile peso per le casse dello Stato. Per individuare tali «fardelli», sono stati attivati dei controlli sistematici, espressamente vietati dalla Commissione, per verificare l’attuale situazione lavorativa di migliaia di uomini e donne, in un contesto in cui i parametri dell’occupabilità non sono chiari e dunque si lascia ampio spazio all’interpretazione. Un altro significativo esempio riguarda il criterio adottato per ottenere il «credito universale» che, in alcune parti del Regno Unito, ha sostituito il sussidio di disoccupazione: esso è vincolato per i migranti, tanto esterni quanto interni alla EU, all’esistenza di «realistiche prospettive» di ottenere un lavoro e al possesso di determinati requisiti, tra cui la conoscenza della lingua inglese. A ciò si accompagnano, in Gran Bretagna, controlli settimanali per verificare che si stia effettivamente cercando lavoro e che non si rifiutino offerte di lavoro, di qualsiasi tipo esse siano. Insomma, non si sputa nel piatto in cui si mangia, anche se la cucina inglese fa discretamente schifo, in particolare quella che paghi con uno stipendio da fame lavorando per i manager incravattati della capitale finanziaria.
Tornando al caso belga, i provvedimenti del governo che hanno condotto alle espulsioni si scontrano anche con il regolamento che prevede la totalizzazione dei contributi nei vari Stati in cui si è lavorato, che è ignorato considerando solo la residenza in Belgio. La trasformazione dei diritti in privilegi non riguarda, dunque, solo il welfare assistenziale, ma anche il welfare contributivo nel suo complesso. Non stupisce che nei discorsi sul turismo sociale raramente vengano menzionati i contributi che i migranti pagano e che spesso, o perché vengono espulsi o perché se ne sono andati, non vengono più restituiti in nessuna forma. Il governo inglese, che ha salutato con particolare favore la sentenza della Corte di Giustizia, non considera probabilmente il fatto che il 60% dei migranti interni che arrivano in Gran Bretagna sono laureati, ma soprattutto che essi beneficiano, secondo le stime, solo del 64% di ciò che hanno versato come contributi, e costituiscono perciò una fonte netta di ricchezza per il paese ospitante, non certo una forma di «parassitismo». Rispetto al decennio precedente, oggi i migranti interni ed esterni hanno il 43% delle possibilità in meno di godere di benefit sociali, anche perché la prassi di chiedere loro sempre più documenti per dimostrare la loro «regolarità» crea sempre nuovi ostacoli alla possibilità di godere del welfare. Anche se si pagano i contributi, pare che una volta perso il lavoro, condizione sempre più frequente in un contesto in cui la precarietà è diventata la norma, si debba semplicemente togliere il disturbo. La vita del turista sociale è piuttosto dura per essere quella di un vacanziere: dovrebbe essere disposto a farsi sfruttare in qualsiasi impiego per qualsiasi salario e a regalare i suoi contributi allo Stato che gentilmente lo sfrutta e che non gli dà un soldo finché non è in grado di dimostrare che è lì davvero, con entusiasmo, per vendersi la pelle. A queste condizioni, i diritti di welfare più che il premio vacanze inseguito dai migranti in giro per l’Europa sembrano briciole, pane secco, che gli Stati vendono a prezzo d’oro.
Nel contesto di una generale riduzione dei servizi di welfare sono infatti riconoscibili tendenze che vanno verso una regionalizzazione della cittadinanza europea. Un processo che però non segna il ritorno del vecchio Stato sociale nazionale, della sua cittadinanza e del suo regime di inclusione ed esclusione. L’azione di confini spaziali – come quelli nazionali – e di confini temporali – come quelli definiti dalla coazione all’occupabilità – sui movimenti di questa forza lavoro transnazionale produce una ridefinizione degli spazi e dei tempi della cittadinanza sociale in Europa che la rende definitivamente intermittente. La negoziazione quotidiana delle prestazioni del welfare è la forma più violenta e diffusa di espropriazione. Come se non bastasse lo sfruttamento del salario, ogni giorno milioni di lavoratrici e di lavoratori vengono espropriati amministrativamente di una quota del loro reddito, essendo loro negato ciò che è loro dovuto e in quanto gli si fa pagare a caro prezzo ciò che è necessario. I diritti negati sono l’espropriazione materiale delle possibilità di organizzare autonomamente la propria vita e la propria mobilità. La pratica della libertà di movimento è il modo attraverso il quale migliaia di uomini e donne cercano individualmente di sottrarsi al regime del salario, anche accettando di lavorare in condizioni di irregolarità che sono meno esposte ai nuovi controlli e possono rivelarsi più redditizie in quanto non comportano il versamento di contributi a fondo perduto. Tuttavia, è necessario creare le condizioni affinché questa risposta sia organizzata sulla stessa scala dell’attacco che abbiamo di fronte. Contro queste spinte la rivendicazione di un welfare europeo e di un salario minimo europeo significa la materiale conquista della libertà di movimento e la possibilità di sottrarsi alle condizioni e agli ostacoli che il governo della mobilità mira a imporle. Un welfare europeo e un salario minimo europeo sono necessari per sottrarsi alla libertà di sfruttamento e di espropriazione imposta dall’Europa degli Stati. Welfare e salario minimo devono perciò avere una portata europea non solo per rispondere a un attacco che, pur articolandosi su differenti livelli e scale di potere, ha una portata europea, ma anche e soprattutto perché, se pensati in chiave nazionale, diventerebbero un nuovo strumento per produrre vecchie gerarchie e intollerabili discriminazioni.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




