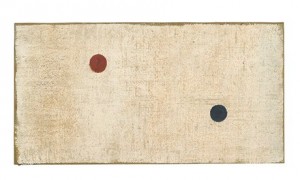 Torniamo a parlare di forconi qualche giorno dopo il 9 dicembre e il giorno prima del fatidico 18 dicembre. Sembra intanto che la replica della marcia su Roma non trovi la sua strada, non per una democratica paura di scatenare la violenza estremista, ma per la consolidata consapevolezza che il grido di dolore non verrà ignorato. I presidi, i blocchi e le promesse di una conflittualità senza mediazioni appaiono così per quello che sono, ovvero episodi della ricerca di un socio politico di minoranza, necessario negli affari quotidiani. Come nel nostro primo intervento ci interessa proporre un’analisi politica della composizione e dei significati di questo movimento. Non ci interessa, invece, né l’abbiamo fatto in precedenza, dare un giudizio sui comportamenti soggettivi di chi ha deciso di andare in piazza a guardare da vicino cosa succedeva. Se poi Marx gli ha detto che sarebbe andato con loro, tanto meglio.
Torniamo a parlare di forconi qualche giorno dopo il 9 dicembre e il giorno prima del fatidico 18 dicembre. Sembra intanto che la replica della marcia su Roma non trovi la sua strada, non per una democratica paura di scatenare la violenza estremista, ma per la consolidata consapevolezza che il grido di dolore non verrà ignorato. I presidi, i blocchi e le promesse di una conflittualità senza mediazioni appaiono così per quello che sono, ovvero episodi della ricerca di un socio politico di minoranza, necessario negli affari quotidiani. Come nel nostro primo intervento ci interessa proporre un’analisi politica della composizione e dei significati di questo movimento. Non ci interessa, invece, né l’abbiamo fatto in precedenza, dare un giudizio sui comportamenti soggettivi di chi ha deciso di andare in piazza a guardare da vicino cosa succedeva. Se poi Marx gli ha detto che sarebbe andato con loro, tanto meglio.
A noi questa occasione serve per ripensare alcune parole come proletarizzazione, ceto medio o piccola borghesia che, più che categorie, sono diventate etichette per ridefinire i confini labili di soggettività difficili da cogliere e da comprendere politicamente. Non riusciamo a entusiasmarci per le analisi che, per affermare gli elementi di novità emersi il 9 dicembre, proclamano l’avvento di una nuova plebe brutta, sporca e cattiva. Non trovavamo soddisfacenti le prime analisi uscite e non condividiamo queste che relegano i proletari nelle periferie non solo della città, ma anche della politica, come se fossero incapaci di articolare un discorso che non sia quello del grugnito e della devastazione. Non è così, e non è vero. Non ci sono e non ci saranno barbari che dalle amorfe periferie con un linguaggio sconosciuto rimedieranno alla nostra impotenza politica, peraltro sempre prudentemente attribuita a una mitologica sinistra che rimane così il centro effettivo del discorso. C’è invece qualcuno che parla anche a nome di alcune centinaia di proletari presenti in quelle piazze e sono le sue parole a stabilire il segno politico di questo movimento. È stato ampiamente rilevato che esso ha tratti sociologicamente e territorialmente differenziati. Politicamente ha però una direzione definita. Infatti, nonostante le dichiarazioni di intenti e le mani sporche, nessuno l’ha attraversato riuscendo a stabilire anche solo occasionalmente una direzione diversa. Per quanto spuria, questa composizione pretende la titolarità di un’azione politica che mira a ricomporre una molteplicità di figure sociali sotto la precisa egemonia di alcune di esse.
Guardando ad esempio dal vicentino, cioè da uno dei territori di quella che un tempo era la fabbrica diffusa di quegli artigiani terzisti che oggi bloccano la tangenziale, non può sfuggire il protagonismo del piccolo imprenditore che si accredita tuttora come colui che 1) procurava il lavoro ai suoi operai, garantendo loro un salario globale fino a prima della crisi non disprezzabile (in cambio di 50/60 ore settimanali), combattendo sul fronte di una competizione spietata; 2) si opponeva allo Stato e a Equitalia, contro l’iniquità delle tasse e l’inettitudine dei politici che danneggiavano tutti indistintamente; 3) organizza oggi i presidi che danno voce a chi non è stato finora in grado di farsi sentire, mentre affondava in crescenti difficoltà per andare avanti. Si riafferma così l’immagine del «paron tre volte bon» con la sua pretesa di parlare a nome di tutti e di rappresentare l’interesse generale.
Il problema non sono i deliri fascisti, che pure ci sono, ma il tentativo di rappresentare socialmente le vittime del lavoro (scomparso) sia tra gli operai disoccupati sia tra gli artigiani falliti. Il moralismo, i tricolori e l’inno nazionale non sono inquietanti o fastidiosi residui del passato, ma le forme simboliche attuali di questa rappresentazione. Questo movimento pretende di tornare ad affermare il lavoro come fondamento della proprietà, un lavoro che non è né un male comune né un bene comune, ma solo un fatto privato. Si afferma così l’idea semplice che negozianti, artigiani e lavoratori impoveriti sono quelli che davvero lavorano, perché con il loro lavoro costruiscono la loro piccola proprietà. In buona misura, questo è un conflitto per il lavoro di ceti che ne affermano la centralità. Questa affermazione del lavoro come fondamento ideologico della società è il punto politicamente più rilevante, perché descrivere un fenomeno sociale non è la stessa cosa di indicarne il significato politico. Quei ceti possono avere un nemico istituzionale, cioè quella parte di «casta» che non li difende, ma hanno anche un orrore reale verso la condizione di quei proletari che non vogliono diventare. Quella che viene chiamata proletarizzazione non è in alcun modo un processo che oggettivamente spinge uniformemente una massa di individui verso la stessa condizione. Non c’è nessun movimento oggettivo che sposta la figurina del ceto medio o che svela il disagio di una borghesia in formato mignon. C’è un campo di battaglia sul quale molti individui lottano come proletari o per non farsi proletarizzare. Per questi ultimi, i proletari sono coloro che non lavorano o che lavorano senza prospettive di affermazione sociale, cioè senza proprietà. Questi proletari però sono reali, uomini e donne, migranti e italiani, bianchi e neri; la ricomposizione può perciò avvenire solo contro di loro e in nome di un sociale uniforme e indifferenziato. È la politica del capitale. Magari dirlo può apparire a qualcuno come un eccesso di ortodossia, soprattutto a coloro che senza arroganza definiscono immediatamente ideologi o intellettuali tutti quelli che non sono d’accordo con loro. Per i maestri di stile e di pensiero che danno lezioni di realtà via Facebook, magari è eccessivo dire che la protesta dei forconi ha l’aspetto di uno sciopero del capitale: non perché tutti coloro che vi partecipano siano capitalisti, bensì perché a essere affermato e confermato è lo specifico rapporto sociale di capitale. Questo sciopero impone di pensare la differenza tra uno «sciopero sociale», per quanto confuso e ambiguo nelle sue manifestazioni, e uno sciopero della società che mira a conservarla nei suoi rapporti gerarchici, erosi e ridisegnati dalle trasformazioni politiche e dalla crisi economica, ma che ci condannano pur sempre alla subalternità. Questo sciopero della società non è un segno del grande disordine che regna sotto il cielo, ma l’irruzione di un comportamento collettivo che non produce alcuna sconnessione nell’ordine del capitale, che è persino disposto a produrre un po’ di disordine pubblico pur reintegrare il suo stesso ordine.
Che le periferie e i padroncini, pur senza essere presenti agli assedi proclamati un paio di mesi fa a Roma, ne siano oggi senza saperlo una parte integrante, pare una pretesa quanto meno bizzarra. Che ciò che sta succedendo segnali l’ennesima crisi della rappresentanza significa averne un’idea davvero approssimativa. La rappresentanza politica è da qualche secolo la manifestazione visibile dei processi di unificazione e di omogeneizzazione della società. Per questo le istituzioni sono ancora lì con un sorriso beffardo a guardarci, incuranti delle pietre e tutto sommato soddisfatte di vedere che, mentre il loro funerale viene ripetutamente rinviato, le folle continuano a raggrupparsi davanti ai loro palazzi. Siamo così sicuri che commercianti e padroncini vogliano rovesciare il quadro istituzionale, recidendo il cordone ombelicale con il capitale? Invece di ripetere il mantra della società contro lo Stato, sarebbe il caso di indagare il tentativo di riaffermare l’egemonia di un soggetto bianco, proprietario e nazionale nelle trasformazioni globali della rappresentanza politica. Proprio perché non soggetti a condizionamenti di vetusta ideologia, noi non pensiamo che lo Stato sia un comitato d’affari che si possa licenziare per inadeguatezza o per inefficienza, ma piuttosto un’escrescenza sociale che riflette e riproduce le contraddizioni che innervano la società.
Ma con quelle contraddizioni dovremmo fare i conti, perché altrimenti passa l’idea che nella crisi della rappresentanza la sola cosa che può essere davvero universalmente rappresentata è il lavoro come fondamento della società. Vogliamo davvero che il rito funebre per le istituzioni si chiuda così? Altre domande. E forse qualcosa di più.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




