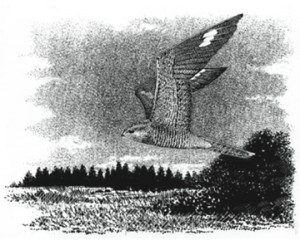C’erano oltre duemila persone sabato scorso a Bologna alla manifestazione per i diritti dei migranti e l’abolizione della Bossi-Fini. La parte schiacciante dei manifestanti erano i migranti stessi, mentre la presenza italiana era rarefatta per l’assenza delle tradizionali forze politiche e sindacali che, pur in modo contraddittorio, avevano sostenuto i lavoratori migranti negli anni scorsi. Un solco del resto già scavato nel 2010, quando le grandi centrali sindacali definirono lo sciopero del primo marzo contro la Bossi-Fini uno sciopero «etnico» e la gran parte dei sindacati di base lo ignorò, usando come paravento l’appoggio a quella giornata da parte di esponenti del PD. Con questi precedenti non stupisce che nessun sindacato, ad esclusione di quello incarnato dagli stessi migranti presenti in piazza, abbia organizzato una sua presenza.
D’altra parte i media avevano ben lavorato nel trascurare la manifestazione: perfino il Manifesto, che pure con tanta oculatezza aveva seguito lo sciopero nella logistica del giorno precedente, di cui la manifestazione era la naturale prosecuzione, non le ha dedicato un francobollo. Eppure i migranti in piazza erano in larga misura quelli che, il giorno precedente, avevano scioperato nelle cooperative del sudore e forse qualche cronista era anche da quelle parti. Duemila persone sono forse un numero risibile, ma comunque superiore a quello di molte iniziative delle quali si tessono le lodi. La cancellazione sistematica di questa presa di parola collettiva anche da parte degli stessi soggetti, delle realtà e degli organi d’informazione di movimento che avevano esaltato lo sciopero del giorno prima non può lasciare indifferenti. Pare che parlare ancora di Bossi-Fini, di confini e di migranti in carne e ossa, per molti compagni sia diventato un problema insormontabile, al punto da preferire il silenzio. Un silenzio eloquente.
Perché questa è l’impressione, tra le accuse di vittimismo sparate a salve e la dichiarazione della fine del razzismo grazie alle lotte. Quella di un imbarazzo politico, della voglia di sbarazzarsi della questione. Non sarà facile. Quei duemila presenti in piazza lo hanno gridato chiaramente. Dopo aver scioperato il giorno prima, volevano esserci per dire la loro a tutti. A leggere le cronache dello sciopero della logistica pare invece di trovarsi di fronte a operai senza nome, senza volto e senza storia. Eppure il lavoro astratto ha lasciato da tempo il posto al lavoro in carne e ossa di operai e operaie sui quali incombe lo stigma della separazione. Fuori dai messaggi in codice e dai tatticismi, viene davvero da chiedersi fino a che punto la talpa del razzismo istituzionale abbia scavato in questi anni, anche all’interno dei movimenti, al punto dal diventare un argomento scomodo e impronunciabile. La giusta fine dell’antirazzismo solidaristico e vittimista, conquistata dai migranti con le lotte, non può diventare un alibi per tacere oggi sulla condizione migrante.
La questione di 5 milioni di persone che non hanno diritto al voto, stritolati da una legislazione razzista che lega indissolubilmente anche la loro libertà personale a un contratto di lavoro e li tiene ancorati al lavoro operaio meno qualificato, non sembra essere in alcuno degli otto o venti punti che le principali forze politiche propagandano come ricetta per cambiare e salvare il paese. Ma scomoda è la questione soprattutto per chi ha scelto l’ingovernabilità pensando di trovarla nel parlamento, salvo poi gioire di fronte ai conflitti che stanno attraversando il settore della logistica, così come quello agricolo. Certo, alle ultime elezioni politiche era difficile poter scegliere una forza politica che si sia mossa con una qualche decenza. Ma il tifo per l’ingovernabilità sembra non cogliere le dinamiche interclassiste e anche un po’ razziste del M5S. Non sarà un caso allora che alla manifestazione c’era una sola neoparlamentare, non appartenente al Movimento, la cui pelle nera non è passata inosservata attirandole minacce di morte non appena eletta, e nessuno di tutti gli altri partiti, perlopiù impegnati, anche legittimamente, altrove.
E il tema scompare anche dal registro di un movimento che dovrebbe almeno ambire ad essere transnazionale e non trovare all’interno dei confini di uno Stato, di un territorio o di una comunità la risposta alle politiche neoliberali della Troika. Per quello esistono già movimenti di destra e un’opinione pubblica che vive sempre con fastidio ogni presa di parola dei migranti. Non è allora un caso che a generare lotte del lavoro finalmente espansive e non più solo difensive siano oggi i lavoratori migranti. Non è nemmeno un caso che molti di loro, che i confini li hanno attraversati e li combattono ogni giorno, abbiano ben chiaro che il nemico che hanno di fronte ha due facce e in due giornate vicine le abbiano volute combattere insieme.
Danno invece molto da pensare amici e compagni che vedono nella proposta del reddito di cittadinanza da parte del M5S una loro vittoria, per poi dimenticarsi di quanti lo pagheranno ma ne saranno esclusi. Come danno da pensare quelli che sabato non solo non c’erano, ma hanno preferito e continuano a preferire il silenzio in ogni loro commento e presa posizione sui risultati elettorali, sulla Tav e anche sugli scioperi fatti e costruiti dai migranti. Fanno arrabbiare alcuni vecchi amici e compagni distratti sul mondo che li circonda che alla ricerca di un paese un po’ più onesto ne costruiscono uno razzista, pronti a scendere in piazza per difendere magistrati. Ma fanno ancora più pensare quelli che ignorano cosa sia cambiato negli ultimi vent’anni nel governo del lavoro, che vede una composizione di classe radicalmente mutata sulla quale pende su scala mondiale, come una minaccia costante, la separazione dell’apartheid democratico. Perché dopo le conquiste operaie sulla pelle dei colonizzati, ora non è il momento di nuove conquiste sulla pelle dei migranti.
Mentre la politica italiana sembra dividersi tra qualche aula parlamentare e qualche sito web, i lavoratori migranti in piazza ci impongono non di annunciare ogni giorno che la rivoluzione è alle porte, ma di decidere se stare dalla parte degli onesti o degli eguali.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione