di PAOLA RUDAN e DEVI SACCHETTO
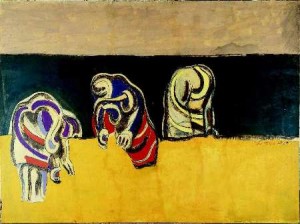 Sciopero ora! È la parola d’ordine che risuona da sabato nella masseria Boncuri di Nardò, a pochi chilometri da Lecce. A gridarla da un megafono sono lavoratori africani giunti da varie parti d’Italia per la raccolta. Chiusa in fretta quella delle angurie, con il 60% del raccolto lasciato a marcire nei campi – complici le importazioni a prezzi stracciati da Grecia e Turchia – i migranti si sono riversati sui pomodori. Anche per questo il salario imposto dai caporali, tutti a loro volta africani, è ancora più basso dell’anno scorso: 3,5 euro per cassone di 100 chili per i pomodori grandi, 7 euro per il ciliegino. Sabato mattina, quando a questo si è aggiunta la richiesta di selezionare il prodotto sui campi prima di infilarlo nei cassoni, è partita spontanea la protesta. Una quarantina di lavoratori si sono rifiutati di continuare il lavoro e son tornati alla masseria, dove da due anni l’associazione Finis Terrae e le Brigate di solidarietà attiva (Bsa) li sostengono per soddisfare alcuni dei bisogni quotidiani e con la campagna “Ingaggiami. Contro il lavoro nero”, iniziata nel 2010. Dopo una veloce riunione alle sei e mezza del mattino, i migranti decidono per il blocco della vicina strada statale che dura però poco a causa dell’immeditato intervento della polizia. La protesta si conclude con la convocazione di un’assemblea nella masseria per il sabato sera da parte della Flai-Cgil locale, arrivata buon’ultima a sostenere le ragioni dei migranti. Il primo a presentarsi è un caporale tunisino, per pagare la settimana di lavoro ed evidentemente per capire la situazione. Rimane poco e poi se ne va, mentre la tensione tra i circa 300-350 lavoratori presenti nella masseria si taglia a fette. Si reclamano aumenti salariali e contratti di lavoro. L’anno scorso le organizzazioni padronali avevano sottoscritto circa 170 contratti, anche sotto la spinta delle prime forme di organizzazione autonoma dei migranti per reclamare migliori condizioni di lavoro. Oggi con un solo contratto, confezionato su misura dai caporali, lavorano anche diverse persone. Ma è difficile pensare che il sistema sia retto solo da caporali stranieri.
Sciopero ora! È la parola d’ordine che risuona da sabato nella masseria Boncuri di Nardò, a pochi chilometri da Lecce. A gridarla da un megafono sono lavoratori africani giunti da varie parti d’Italia per la raccolta. Chiusa in fretta quella delle angurie, con il 60% del raccolto lasciato a marcire nei campi – complici le importazioni a prezzi stracciati da Grecia e Turchia – i migranti si sono riversati sui pomodori. Anche per questo il salario imposto dai caporali, tutti a loro volta africani, è ancora più basso dell’anno scorso: 3,5 euro per cassone di 100 chili per i pomodori grandi, 7 euro per il ciliegino. Sabato mattina, quando a questo si è aggiunta la richiesta di selezionare il prodotto sui campi prima di infilarlo nei cassoni, è partita spontanea la protesta. Una quarantina di lavoratori si sono rifiutati di continuare il lavoro e son tornati alla masseria, dove da due anni l’associazione Finis Terrae e le Brigate di solidarietà attiva (Bsa) li sostengono per soddisfare alcuni dei bisogni quotidiani e con la campagna “Ingaggiami. Contro il lavoro nero”, iniziata nel 2010. Dopo una veloce riunione alle sei e mezza del mattino, i migranti decidono per il blocco della vicina strada statale che dura però poco a causa dell’immeditato intervento della polizia. La protesta si conclude con la convocazione di un’assemblea nella masseria per il sabato sera da parte della Flai-Cgil locale, arrivata buon’ultima a sostenere le ragioni dei migranti. Il primo a presentarsi è un caporale tunisino, per pagare la settimana di lavoro ed evidentemente per capire la situazione. Rimane poco e poi se ne va, mentre la tensione tra i circa 300-350 lavoratori presenti nella masseria si taglia a fette. Si reclamano aumenti salariali e contratti di lavoro. L’anno scorso le organizzazioni padronali avevano sottoscritto circa 170 contratti, anche sotto la spinta delle prime forme di organizzazione autonoma dei migranti per reclamare migliori condizioni di lavoro. Oggi con un solo contratto, confezionato su misura dai caporali, lavorano anche diverse persone. Ma è difficile pensare che il sistema sia retto solo da caporali stranieri.
Certo, sono loro che gestiscono il mercato del lavoro nella raccolta dei cocomeri e dei pomodori: «un tunisino è il capo dei caporali e poi ci sono sudanesi, ghanesi. Ognuno cerca di assumere i suoi connazionali», afferma Françoise, un trentenne togolese da quattro anni in Italia. Ogni caporale straniero recluta le sue squadre di lavoro alle quattro del mattino, sulla base di una trattativa al ribasso sul salario. I lavoratori conoscono la realtà del lavoro migrante, così come sanno che ci sono «diverse categorie di migranti», che quelli senza un permesso di soggiorno accettano, talvolta, le condizioni salariali peggiori. Sono gli effetti ordinari della Bossi-Fini, che si fanno sentire dalle fabbriche del nord alla fabbrica verde del sud d’Italia. I lavoratori reclutati sono stipati nei pulmini: «il trasporto si paga tre euro, ma poi nei campi ti fanno pagare anche il panino, l’acqua, le sigarette», racconta Abdellah un tunisino che da settembre a giugno lavora nell’agricoltura del trapanese. E i rumors tra i migranti sono che il datore di lavoro paghi 10 euro per cassone con pomodori grandi, 15 euro per il ciliegino: 6-7 euro a cassone si dividono tra le vari intermediazioni che nessuno conosce bene. Per questo i lavoratori in sciopero pretendono di «trattare direttamente con le aziende».
Questo sistema di mediazione – che ricalca per certi versi l’organizzazione frammentata ed esternalizzata del lavoro industriale – è la forma consolidata della produzione e dello sfruttamento nell’agricoltura, che si regge sempre più, quando non esclusivamente, sul lavoro migrante. A monte ci sono cinque, sei aziende: 600-700 ettari ciascuna destinati a cocomeri e pomodori. Esse affidano talvolta ad altre imprese il lavoro di raccolta, seguendo le regole del sub-appalto: vendere i prodotti sui campi e quindi affidare ai sub-appaltatori oneri e onori della raccolta e della commercializzazione. Una strutturazione produttiva continuamente modificata poiché essa funziona come uno spazio politico nel quale le convenienze cambiano rapidamente. Catene del sub-appalto e del caporalato si intrecciano in modo stretto.
Il caporalato trae linfa vitale dall’isolamento della manodopera: le condizioni di vita e di lavoro peggiorano, infatti, quando i lavoratori sono sistemati in luoghi lontani dai centri abitati, come l’esperienza delle campagne foggiane è lì a dimostrarci. Il costo dell’acqua, del cibo, del trasporto, delle sigarette lievita, e diventa impossibile uno scambio di esperienze e forme di organizzazione. I migranti che scendono dal settentrione ben conoscono il legame tra isolamento fisico, sociale e politico: il miracolo del nordest fatto di piccole imprese disperse in mezzo alle campagne si è retto anche su questo. Eppure, queste campagne salentine, grazie anche a Finis Terrae e alle Bsa, sembrano in grado di produrre nuove relazioni sociali aggreganti e forse anche un reciproco tendenziale riconoscimento di una comunanza di destino.
Quest’anno l’organizzazione autonoma dei lavoratori migranti sembra più articolata, forse anche perché il lavoro è scarso e il malcontento diffuso: in molti hanno lavorato non più di tre, quattro giorni nell’ultimo mese e mezzo. Dopo la disastrata raccolta dei cocomeri un cospicuo numero di tunisini se n’è andato e il campo è composto prevalentemente da migranti sub-sahariani, tutti maschi dai 25 ai 40 anni circa, sebbene qualcuno arrivi anche ai 50 anni. Tra i lavoratori africani, accanto a un cospicuo numero di richiedenti asilo, vi sono operai espulsi dalle fabbriche settentrionali alla ricerca di un ammortizzatore sociale durante i mesi estivi, oppure braccianti moderni che seguono le raccolte: Foggia, Palazzo San Gervasio, Rosarno. Solo una piccola parte è sprovvista del permesso di soggiorno, mentre più consistente è il numero di quanti possono contare su un permesso umanitario o sono in attesa dello status di rifugiato. Tra gli irregolari, molti sono usciti da poco da un centro di detenzione dopo aver attraversato il Mediterraneo in fuga dal conflitto libico. Ospitati in 28 tende messe a disposizione dalla provincia di Lecce oppure arrangiandosi con tende personali, possono usufruire dei servizi base: acqua potabile, docce calde, water chimici, corrente elettrica, presenza di un medico dell’Asl locale dalle 17 alle 22, assistenza legale. Il cibo viene preparato, per 3-4 euro a pasto, da altri migranti che si dedicano esclusivamente a questa attività in baracche collocate nell’area della masseria.
Burkinabé, ghanesi, sudanesi, tunisini sembrano decisi a resistere. Eppure le pressioni sono forti: Yvan, uno studente camerunense del Politecnico di Torino, vero leader della protesta, all’assemblea di lunedì sera al megafono di fronte alle televisioni locali spiegava con assoluta calma di aver ricevuto minacce di morte da parte dei caporali. Nessuno dubitava delle sue parole. Ma anche stamani alle tre del mattino i più combattivi tra i migranti hanno costruito sbarramenti di fortuna per impedire ai caporali di caricare qualche crumiro. Mentre i giornali locali, La Gazzetta del Mezzogiorno in prima fila, cercano di spegnere l’incendio scrivendo che la maggior parte dei migranti vuole tornare al lavoro.
La lotta di questi giorni non si è strutturata attorno a una linea comunitaria. I lavoratori migranti di Nardò non condividono lingua o nazionalità, ma un obiettivo – il miglioramento delle condizioni salariali e di lavoro – e l’idea che sia lo sciopero lo strumento attraverso il quale conseguirlo. Uno sciopero praticato nonostante la precarietà radicale delle condizioni di vita e di lavoro, uno sciopero fatto anche per quanti più ricattabili dalla clandestinità che la Bossi-Fini sistematicamente produce. Salento: sole, mare e sfruttamento, recitava una scritta di qualche anno fa su un muro di un paesino poco lontano da Nardò: i coraggiosi lavoratori africani sembrano in grado di far cambiare il vento.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




