di PAOLA RUDAN
Una versione abbreviata di questa recensione è stata pubblicata su “Il Manifesto” del 29 novembre 2019
 «Macerie del neoliberalismo»: così, nel suo ultimo libro (In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West, Columbia University Press, 2019), Wendy Brown definisce l’emergenza delle politiche antidemocratiche in Occidente, l’ascesa di movimenti e partiti di estrema destra e ultranazionalisti negli Stati Uniti e in Europa, la violenta politicizzazione dei valori della tradizione giudaico-cristiana che sostiene la guerra aperta contro le donne, le minoranze sessuali, i migranti. Per muoversi tra le macerie del neoliberalismo bisogna afferrare il senso del genitivo: la politica «sregolata, populista e brutta» della «destra dura» [hard-right] non è il residuo di un ordine politico e sociale andato in rovina, ma l’effetto di un discorso che radica la libertà del mercato in un sistema morale ostile a ogni pretesa di uguaglianza. È un effetto imprevisto almeno se, come fa Brown, si mettono a confronto la teoria neoliberale e il «neoliberalismo reale». È un effetto Frankenstein – la creatura che si ribella al suo creatore – del quale lei cerca di ricostruire la «razionalità» facendo un passo avanti rispetto al suo lavoro del 2015, Undoing the Demos. Non è più sufficiente considerare come il neoliberalismo «disfa il popolo» universalizzando la figura dell’homo oeconomicus e cancellando dalla scena l’homo politicus, il cittadino democratico. Bisogna dare conto, secondo Brown, del modo in cui esso ha alimentato la «cultura antidemocratica dal basso» che ha legittimato «forme antidemocratiche di potere statale dall’alto». Bisogna ricercare, all’interno dei termini del discorso neoliberale, il processo di «produzione di soggettività» che permette di spiegare la traumatica e insopportabile elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America.
«Macerie del neoliberalismo»: così, nel suo ultimo libro (In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West, Columbia University Press, 2019), Wendy Brown definisce l’emergenza delle politiche antidemocratiche in Occidente, l’ascesa di movimenti e partiti di estrema destra e ultranazionalisti negli Stati Uniti e in Europa, la violenta politicizzazione dei valori della tradizione giudaico-cristiana che sostiene la guerra aperta contro le donne, le minoranze sessuali, i migranti. Per muoversi tra le macerie del neoliberalismo bisogna afferrare il senso del genitivo: la politica «sregolata, populista e brutta» della «destra dura» [hard-right] non è il residuo di un ordine politico e sociale andato in rovina, ma l’effetto di un discorso che radica la libertà del mercato in un sistema morale ostile a ogni pretesa di uguaglianza. È un effetto imprevisto almeno se, come fa Brown, si mettono a confronto la teoria neoliberale e il «neoliberalismo reale». È un effetto Frankenstein – la creatura che si ribella al suo creatore – del quale lei cerca di ricostruire la «razionalità» facendo un passo avanti rispetto al suo lavoro del 2015, Undoing the Demos. Non è più sufficiente considerare come il neoliberalismo «disfa il popolo» universalizzando la figura dell’homo oeconomicus e cancellando dalla scena l’homo politicus, il cittadino democratico. Bisogna dare conto, secondo Brown, del modo in cui esso ha alimentato la «cultura antidemocratica dal basso» che ha legittimato «forme antidemocratiche di potere statale dall’alto». Bisogna ricercare, all’interno dei termini del discorso neoliberale, il processo di «produzione di soggettività» che permette di spiegare la traumatica e insopportabile elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America.
Il punto di vista dal quale muove la critica di Brown è democratico. Per lei la democrazia non è semplicemente una forma di governo, ma un processo continuamente teso alla realizzazione dell’uguaglianza politica. Questa definizione ideale ‒ «fuggitiva», per dirla con le parole di Sheldon Wolin ‒ della democrazia non nega le disuguaglianze materiali che caratterizzano la società capitalistica, ma indica la possibilità di contestarle avanzando nei confronti dello Stato rivendicazioni di uguaglianza. Così intesa, la democrazia coincide con la costruzione della società come spazio in cui posizioni differenti e altrimenti separate condividono un «destino», in cui gerarchie altrimenti depoliticizzate possono essere trattate come l’effetto di poteri sociali che impediscono la piena realizzazione dell’uguaglianza politica. La società è il luogo nel quale quegli effetti possono essere contrastati a partire da una comune aspirazione alla giustizia sociale. La prospettiva di Brown è antitetica al neoliberalismo nella misura in cui questo ha cercato di «distruggere concettualmente, normativamente e praticamente la società», di neutralizzare ogni istanza collettiva avanzata in nome dell’uguaglianza, di occultare l’azione e l’eredità di poteri sociali quali patriarcato, schiavitù e colonialismo attraverso l’appello alla responsabilità individuale e al carattere indiscutibile delle regole del mercato. La celebre frase di Margaret Thatcher ‒ «la società non esiste, esistono solo individui, uomini donne e famiglie» ‒ è l’espressione politicamente efficace di un discorso che, a partire da Hayek, tratta la società come una «frode semantica» per neutralizzare i movimenti democratici e le loro pretese politiche. Sotto la patina con cui il neoliberalismo nasconde l’azione dei poteri sociali, prende piede una concezione della libertà che si traduce nell’illimitata espressione del risentimento dell’uomo bianco della working e middle class, la figura che le politiche neoliberali hanno privato dei «privilegi» dispensati dallo Stato sociale novecentesco. La «destra dura» si fa strada quando lo smembramento del legame e delle aspirazioni alla giustizia sociale legittima in nome della libertà il suprematismo dell’uomo bianco.
Smantellare la società significa «detronizzare la politica», un’operazione che Brown ricostruisce attraverso l’analisi di alcuni «classici» del neoliberalismo (Friedman e Hayek) e dell’ordoliberalismo (Röpke e Böhm). Anche in questo caso, l’analisi si articola a partire da un punto di vista democratico, ovvero da una concezione del «politico» che ‒ con una presa di distanza da Schmitt e Marx tanto esplicita quanto analiticamente discutibile ‒ lei definisce come il teatro in cui l’esistenza comune è pensata e governata. Nella misura in cui – secondo la sua lettura di Foucault – il politico si manifesta storicamente attraverso forme di «razionalità» diverse e contingenti, il problema di Brown è di individuare i momenti in cui la «razionalità neoliberale» ha spodestato quella democratica che ha dato forma allo Stato sociale del XX secolo. Il neoliberalismo si configura così come una stratificazione di strategie discorsive volte a delegittimare ogni azione sovrana tesa a correggere le disuguaglianze. Nel caso di Milton Friedman, lo Stato non deve intervenire o può farlo soltanto per sostenere le dinamiche del mercato, perché il capitalismo è autonomamente in grado di alimentare e realizzare la libertà individuale. Nel caso di Hayek, la concezione schmittiana della sovranità ‒ l’idea che vi sia un principio volontaristico e decisionistico che dà forma alla società ‒ deve essere sconfessata in nome di una comprensione dell’ordine come risultato di regole impadroneggiabili che si sono evolute organicamente nel corso della storia e che devono essere tanto preservate da ogni indebita ingerenza politica, quanto sostenute politicamente. Nel caso di Röpke e Böhm quelle regole, espressione di una cultura e di un ethos nazionali, danno consistenza alla «costituzione economica». Questa deve essere difesa e resa operativa da uno Stato che, diversamente da quello sociale, non è «integrato» nell’economia, ma autonomamente la sostiene. In nessuna di queste strategie lo Stato è irrilevante, ma tutte ne affermano l’autonomia negando allo stesso tempo la «priorità» della politica rispetto all’economia. Tutte, d’altra parte, rifiutano quella che Brown definisce «democrazia robusta», ovvero le rivendicazioni di carattere egualitario rivolte allo Stato e nelle quali si esprime una concezione espansiva del politico. L’esito imprevisto di questi discorsi sono politiche statuali che, lungi dall’essere autonome, sono sempre più strumentalizzate dal grande capitale, che impone la libertà del mercato in forme tecnocratiche e autoritarie esponendo la cittadinanza a mobilitazioni nazionalistiche.
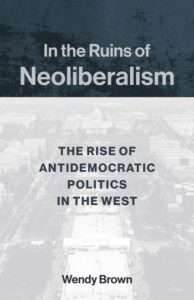 C’è infine un terzo aspetto del discorso neoliberale che, secondo Brown, ha creato le condizioni per l’affermazione delle politiche antidemocratiche contemporanee e che consiste nel suo costante riferimento ai valori morali tradizionali. Distinguendosi da altre recenti letture del rapporto tra neoliberalismo e neoconservatorismo, Brown non tratta il secondo come un «supplemento» necessario ad arginare gli effetti «nichilistici» del primo (Irving Kristol), non si limita a osservare la «risonanza» manifesta nell’estremismo ideologico con il quale i due discorsi attaccano le élite culturali (Tim Alberta) o difendono la libertà di mercato e i valori tradizionali (William Connoly), e cerca infine di andare oltre la constatazione della loro «convergenza» in merito alla funzione della famiglia tradizionale come puntello delle politiche di smantellamento del welfare (Melinda Cooper). Il passo avanti che Brown cerca di compiere rispetto a ciascuna di queste letture consiste piuttosto nel riconoscere il ruolo della moralità tradizionale «all’interno» della ragione neoliberale. Nella sua analisi, il discorso di Hayek si rivela perciò esemplare per via della contrapposizione che egli stabilisce tra un insieme di norme valoriali radicate nella storia e passibili di trasformazioni evolutive, la sovranità democratica e lo Stato sociale. Per Hayek, la tradizione ha il potere di promuovere una «conformità volontaria» che si manifesta nella condotta abituale degli individui. In quanto «spontaneo» l’ordine della tradizione ‒ che è poi quello della famiglia patriarcale, della disciplina e dell’autorità che essa riproduce ‒ è quindi omologo a quello del mercato e come quello del mercato deve essere tutelato dalle ingerenze dello Stato pianificatore e dalla sua pretesa di legiferare e intervenire sulla condotta individuale. Affinché i valori tradizionali si sviluppino a partire dalla libertà, perciò, non è sufficiente difendere la proprietà privata, ma è necessario espandere il più possibile la «sfera personale protetta» dall’intervento politico statuale. Ciò che Hayek non avrebbe previsto è la violenta politicizzazione dei valori tradizionali conseguente a quell’espansione. In particolare, il diritto di professare la propria fede in pubblico si traduce nella legittimazione dei discorsi d’odio contro le minoranze sessuali, i migranti, gli islamici, nella rinnovata presenza delle congregazioni religiose all’interno delle istituzioni scolastiche e sociali, nell’attacco senza quartiere alle politiche «affermative», a quelle dei diritti e al carattere laico dello Stato. Il nazionalismo contemporaneo – che tratta la nazione come una grande famiglia che deve essere posta sotto la tutela di un padre che la protegga dalle minacce che la assediano ‒ attecchisce proprio sul terreno della politicizzazione dei valori tradizionali. L’ordine del presente è quindi tutt’altro che spontaneo, perché lo Stato impone autoritativamente il mercato e perché i valori tradizionali non si affermano tramite la conformità volontaria ma attraverso la loro violenta agitazione politica e l’intervento attivo delle corti di giustizia, cui Brown dedica il quarto capitolo del libro. Alle spalle di Trump, ancora una volta, ci sarebbe il risentimento dell’uomo bianco della working e middle class che si scaglia contro le élite cosmopolite che sostengono il femminismo, le forme «non normative» della sessualità e quelle non tradizionali della famiglia, la laicità dello Stato e un’educazione liberale e democratica.
C’è infine un terzo aspetto del discorso neoliberale che, secondo Brown, ha creato le condizioni per l’affermazione delle politiche antidemocratiche contemporanee e che consiste nel suo costante riferimento ai valori morali tradizionali. Distinguendosi da altre recenti letture del rapporto tra neoliberalismo e neoconservatorismo, Brown non tratta il secondo come un «supplemento» necessario ad arginare gli effetti «nichilistici» del primo (Irving Kristol), non si limita a osservare la «risonanza» manifesta nell’estremismo ideologico con il quale i due discorsi attaccano le élite culturali (Tim Alberta) o difendono la libertà di mercato e i valori tradizionali (William Connoly), e cerca infine di andare oltre la constatazione della loro «convergenza» in merito alla funzione della famiglia tradizionale come puntello delle politiche di smantellamento del welfare (Melinda Cooper). Il passo avanti che Brown cerca di compiere rispetto a ciascuna di queste letture consiste piuttosto nel riconoscere il ruolo della moralità tradizionale «all’interno» della ragione neoliberale. Nella sua analisi, il discorso di Hayek si rivela perciò esemplare per via della contrapposizione che egli stabilisce tra un insieme di norme valoriali radicate nella storia e passibili di trasformazioni evolutive, la sovranità democratica e lo Stato sociale. Per Hayek, la tradizione ha il potere di promuovere una «conformità volontaria» che si manifesta nella condotta abituale degli individui. In quanto «spontaneo» l’ordine della tradizione ‒ che è poi quello della famiglia patriarcale, della disciplina e dell’autorità che essa riproduce ‒ è quindi omologo a quello del mercato e come quello del mercato deve essere tutelato dalle ingerenze dello Stato pianificatore e dalla sua pretesa di legiferare e intervenire sulla condotta individuale. Affinché i valori tradizionali si sviluppino a partire dalla libertà, perciò, non è sufficiente difendere la proprietà privata, ma è necessario espandere il più possibile la «sfera personale protetta» dall’intervento politico statuale. Ciò che Hayek non avrebbe previsto è la violenta politicizzazione dei valori tradizionali conseguente a quell’espansione. In particolare, il diritto di professare la propria fede in pubblico si traduce nella legittimazione dei discorsi d’odio contro le minoranze sessuali, i migranti, gli islamici, nella rinnovata presenza delle congregazioni religiose all’interno delle istituzioni scolastiche e sociali, nell’attacco senza quartiere alle politiche «affermative», a quelle dei diritti e al carattere laico dello Stato. Il nazionalismo contemporaneo – che tratta la nazione come una grande famiglia che deve essere posta sotto la tutela di un padre che la protegga dalle minacce che la assediano ‒ attecchisce proprio sul terreno della politicizzazione dei valori tradizionali. L’ordine del presente è quindi tutt’altro che spontaneo, perché lo Stato impone autoritativamente il mercato e perché i valori tradizionali non si affermano tramite la conformità volontaria ma attraverso la loro violenta agitazione politica e l’intervento attivo delle corti di giustizia, cui Brown dedica il quarto capitolo del libro. Alle spalle di Trump, ancora una volta, ci sarebbe il risentimento dell’uomo bianco della working e middle class che si scaglia contro le élite cosmopolite che sostengono il femminismo, le forme «non normative» della sessualità e quelle non tradizionali della famiglia, la laicità dello Stato e un’educazione liberale e democratica.
L’astio nutrito dalla working e middle class verso quelle élite sembrerebbe reciproco, almeno considerando il modo in cui Brown si allinea più o meno esplicitamente agli intellettuali liberal nordamericani che hanno accusato gli operai della cosiddetta rust belt per aver dato il via all’incubo trumpiano. Da parte sua non c’è attenzione al carattere antidemocratico del sistema elettorale statunitense, né alla lettura del voto del 2016 che ha sia ridimensionato il sostegno a Trump da parte della classe operaia negli Stati decisivi della rust belt, sia rivelato quello che gli hanno sorprendentemente accordato le donne bianche. Il problema non è di correggere l’analisi di Brown con scrupolo politologico, ma di riconoscere che i processi dei quali il tycoon americano è la rappresentazione esteticamente deplorevole e politicamente vincente non possono essere letti solo attraverso le lenti della politica del «risentimento» alla quale lei ricorre da anni per spiegare i processi neoliberali di «produzione di soggettività». Integrare Nietzsche con l’idea marcusiana di una «desublimazione della volontà di potenza» non aggiunge nulla alla sua consueta analisi e al massimo spiega, con una discutibile generalizzazione psicologica, la fenomenologia della violenza con cui la «destra dura» si esprime. Certamente, quell’integrazione non permette di dare conto ‒ come pure Brown ha fatto in passato, analizzando le cosiddette identity politics attraverso la nietzscheana genealogia della morale ‒ della domanda di giustizia che paradossalmente anima una parte delle donne che hanno sostenuto il nazionalismo economico di Trump nella convinzione che avrebbe protetto i loro salari meglio del «femminismo del farsi avanti» di Hillary Clinton. L’analisi di Brown, d’altra parte, manifesta indifferenza anche verso le condizioni materiali di esistenza di quei migranti documented che hanno considerato il muro di confine una possibile protezione dalla concorrenza del lavoro migrante undocumented, sapientemente gestita dal governo neoliberale della mobilità attraverso la sua ideologia razzista. I benefici del welfare state di cui working e middle class hanno goduto nel secondo dopoguerra non possono essere considerati soltanto «privilegi» la cui perdita genera risentimento senza considerare che è stato proprio lo Stato sociale e democratico a renderli tali, neutralizzando attraverso politiche patriarcali e razziste la pretesa collettiva di conquistare una vita migliore. Quella pretesa ha animato le lotte che nel XX secolo hanno messo in movimento anche la «democrazia fuggitiva» alla quale Brown si ispira, e nel novembre 2015 non ha trovato altro sbocco che una fiducia a termine concessa individualmente al protezionismo trumpiano. Alla fine, quelle lotte giacciono sepolte non soltanto dalle macerie del neoliberalismo, ma anche dalla critica che cerca di dissiparne gli effetti nefasti.
Benché abbia il pregio di non liquidare l’emergenza delle destre contemporanee come un ritorno del fascismo, riconoscendovi invece una nuova e specifica forma di razionalità politica, quella offerta da Brown finisce così per essere una critica solo speculativa e in fondo speculare e opposta al programma neoliberale e alle macerie che produce: essa lavora esclusivamente sul piano della razionalità e le oppone una diversa razionalità, quella democratica, che viene costruita a partire dalla definizione di ciò che il neoliberalismo rifiuta e contesta. L’esito di questo approccio è duplice: prima di tutto, esso replica più o meno inavvertitamente l’operazione neoliberale di cancellazione dei poteri sociali che determinano materialmente la posizione degli individui e le condizioni politiche e istituzionali di riproduzione dell’ordine neoliberale. In questa prospettiva, mentre la democrazia finisce per essere niente più che un’ideale – un «discorso» che si estenua nel tentativo di produrre i suoi «effetti di verità» ‒ la sua invocazione comporta anche un’idealizzazione dello Stato come mediatore necessario tra gli individui e la giustizia sociale, un’idealizzazione che non solo rinuncia a considerare i poteri sociali che si sono espressi attraverso lo Stato sociale del XX secolo, ma non dice nemmeno come invertire la rotta stabilita dalla sua ulteriore trasformazione in funzione del capitale e perdita di autonomia nel contesto globale. In secondo luogo, la forma speculativa della critica di Brown impedisce di considerare l’esistenza di processi di soggettivazione che non siano esclusivamente prodotti dalla razionalità neoliberale. Al di là di un unico riferimento a Black Lives Matter e Occupy Wall Street non si trova traccia, nel libro di Brown, delle lotte per il salario minimo di 15 dollari che hanno attraversato gli Stati Uniti negli ultimi anni, delle massicce mobilitazioni femministe contro Trump e contro la sempre più diffusa penalizzazione dell’aborto a livello statale, degli scioperi delle insegnanti che si sono diffusi da una costa all’altra del paese, delle proteste dei migranti e della solidarietà antirazzista contro le politiche delle deportazioni. Sono queste lotte che hanno reso possibile una politicizzazione del sociale che tuttavia non coincide con la democratica configurazione di un «destino comune» tra soggetti diversi, ma con l’affermazione di linee di antagonismo che attraversano la società neoliberale, che resistono a ogni neutralizzazione, che sfidano la violenza patriarcale, razzista e dello sfruttamento e che non possono essere ridotte alla contrapposizione intellettualistica tra masse antidemocratiche ed élite liberal globali. Proprio perché non riconosce quelle linee di antagonismo e la sua critica non esce dai confini della teoria politica, Brown in definitiva considera la «destra dura» come l’unica ribellione in atto contro il discorso neoliberale e chiude il suo libro domandandosi come possono una «critica politica e visione di sinistra» raggiungere i «resti affettivi» mobilitati dalla destra ‒ l’attaccamento alla nazione, alla famiglia, alla proprietà e alla bianchezza ‒ per trasformarli. Espressione raffinata della radical philosophy contemporanea, Brown finisce anche per mostrarne i limiti politici. La sua critica delle macerie del neoliberalismo, infatti, resta intrappolata nella logica delle razionalità e nel gioco dei discorsi entro cui si muove.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




