di MAURIZIO RICCIARDI
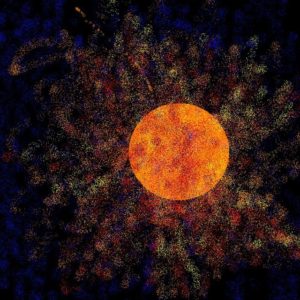 … “società” è una connessione di uomini in riferimento alla loro esistenza, e cioè sullo stesso piano in cui il pezzo di pane mangiato da uno non sazia l’altro.
… “società” è una connessione di uomini in riferimento alla loro esistenza, e cioè sullo stesso piano in cui il pezzo di pane mangiato da uno non sazia l’altro.
Alfred Sohn-Rethel
Non è il caso di essere troppo preoccupati per la fine dello Stato. Nonostante la crisi delle sue istituzioni e le trasformazioni della sovranità, nonostante l’incertezza dei suoi confini, nonostante l’alchimia delle formule di governo, quando serve lo Stato è sempre grado di fare il suo mestiere. Lo fa nei confronti dei migranti, in Val di Susa, garantendo l’istituzionalizzazione della precarietà, oppure, come stanno facendo in queste settimane l’Italia e l’India, difendendo a “colpi di Stato” i frammenti delle nuove sovranità commerciali, di un anacronistico onore militare, di un nazionalismo paradossale e ferito. Lo Stato fa il suo mestiere anche quando sembra ridursi a ingranaggio evanescente all’interno del dominio inafferrabile della governance globale. Allo stesso tempo, tuttavia, lo Stato ha smesso i panni del garante di una distribuzione politicamente contrattata del prodotto sociale. In fin dei conti lo Stato sembra essere tanto più presente a ridosso dei suoi mobili confini interni ed esterni, quanto meno risulta attivamente e programmaticamente presente nel riequilibrio dei rapporti interni alla sua società. Lo Stato sembra declinare come luogo di sintesi del potere, per essere sostituito da altre istituzioni quali, per esempio, le banche spesso individuate come le nuove signore assolute del gioco, perché allo stesso tempo mandanti e beneficiarie della crisi attuale. Il ruolo nefasto delle banche non può certo essere messo in questione. Altrettanto fuori discussione è l’incapacità dello Stato a stabilire sovranamente le condizioni di creazione del credito e le politiche del proprio bilancio. È invece discutibile che le banche siano davvero in grado di legittimare nel tempo un dominio sociale, quasi una tirannia autocratica, senza una qualsivoglia mediazione politica. Risulta però ancora più problematico assumere lo Stato come controparte privilegiata delle proprie rivendicazioni, restaurandolo in una posizione che non occupa più e non vuole più occupare. Siamo di fronte a generale ricollocazione dei luoghi del potere, che impone scelte ragionate nell’identificazione dei luoghi del conflitto.
Non si può registrare in continuazione la crisi della rappresentanza per poi rivolgersi allo Stato quasi ci fosse una sorta di nostalgia della rappresentanza stessa. Proprio per questo è inutile risvegliare dal suo giusto sonno una contrapposizione tra Stato e società che semplicemente non esiste. Se lo Stato è finito da qualche parte, è finito nella società, non però come garante della sua totalità, ma come sua struttura parziale, sottosistema del sistema mondiale della società. In maniera del tutto conseguente la supremazia della società sullo Stato muta le condizioni di possibilità della politica sociale, al punto da rendere poco plausibile scegliere lo Stato come controparte privilegiata per ristabilire le tutele giuridiche del salario o simmetricamente per ottenere un reddito contro la precarietà. Come non è nella condizione di difendere il salario dalla miseria, lo Stato non può, in forza di una decisione politica autonoma, concedere un reddito che salvaguardi dalla cupa avidità del capitale, perché ciò imporrebbe una presenza costante all’interno dei rapporti sociali che semplicemente non c’è più. Al di là di ogni analisi giuridica e istituzionale, nella sovranità statale è cambiata la continuità nella gestione dei problemi di cui pure è investita. La privatizzazione di moltissimi ambiti di decisione politica comporta il riconoscimento della presenza di altri poteri e la legittimazione dei loro tempi. La sovranità forse non è mai stata la capacità di imporre ogni singola decisione contro qualsiasi volontà. Essa è però stata a lungo uno specifico potere sul momento e la durata delle decisioni. La mancanza di questa continuità nel tempo è uno dei sintomi più rilevanti della trasformazione della sovranità. Il lampeggiare – né occasionale né contingente – dello Stato in tutti gli spazi in cui materialmente si manifestano le contraddizioni del dominio capitalistico sconsiglia dunque di fare troppo affidamento sul potere politico per contrastare il potere sociale del denaro. Il potere che oggi sorge dai rapporti sociali è in grado di aggirare ogni resistenza che assuma la forma parziale del politico statale. La domanda che ci si deve allora porre non riguarda tanto la fine o la scomparsa dello Stato, ma: che fine ha fatto la società? Per rispondere a questa domanda si deve partire dalla massa enorme di precarie, migranti, operai ai quali viene quotidianamente spiegato che la società esige da loro sacrificio, silenzio e sfruttamento. Il punto di partenza non è il debito pubblico, ma l’enorme e quotidiano debito verso la società imposto a ogni precaria, a ogni migrante, a ogni operaio. Questo debito non è misurato in denaro, perché il denaro è esattamente il mezzo destinato a cancellarlo e a negarlo. Che società è quella fondata su un debito da pagare quotidianamente, mentre ogni possibile credito è senza tempo, rimandato a un’altra generazione, a un altro lavoro, a un altro luogo? Che società è quella in cui il capitale può sfruttare ogni risorsa naturale, umana e sociale, grazie al monopolio della mobilità che lo mette nella condizione di sfuggire alle contestazioni che lo inseguono e alle conseguenze che la sua azione produce?
È dunque bene capire com’è cambiata la società. Se lo Stato nazione è in crisi, una società nazionale non esiste certamente più. Non esiste più da nessuna parte una società omogenea e con forme ovunque simili di regolazione in uno spazio rigorosamente delimitato. Stiamo assistendo al consolidamento di una società mondiale, nella quale le forme di coazione gerarchica al lavoro stanno diventando ancora più cogenti. Il segno distintivo di questa società mondiale non è l’inclusione universale. Essa è piuttosto resa possibile dalla costante produzione di una gerarchia delle differenze, che solo un insano ottimismo può considerare come l’effetto temporaneo di una globalizzazione ancora incerta o incompleta. La società mondiale non è caratterizzata nemmeno in prospettiva dall’ampliamento di riconoscimenti e inclusioni per il momento ancora insufficienti. Il paradosso della società mondiale è proprio quello di coinvolgere tutti gli individui nello stesso movimento complessivo mentre, allo stesso tempo, diviene sempre più difficile rintracciare forme di reciprocità tra gli individui e la società nel suo complesso. Il paradosso di questa società mondiale è che il massimo di coazione da parte della società coincide con una società inconsistente o addirittura assente. Per essere più chiari: mentre i rapporti che caratterizzano questa società mondiale impongono a un numero sempre maggiore di individui di sacrificarsi in nome della società, della sua tenuta, della sua riproduzione, questi stessi uomini e queste stesse donne si vedono restituiti sempre meno salario, meno reddito, meno possibilità di accedere alle prestazioni del welfare. Più di ogni altra figura, in questa società mondiale, i migranti si scontrano con questa sorta di assenza strutturale di società. Tocca a loro, infatti, attraversare gli spazi nazionali e transnazionali per trovarsi in continuazione di fronte alla negazione di riconoscimento che è giuridica solo perché è in primo luogo materiale. L’assenza di società che vivono i migranti non segnala ovviamente la mancanza di forme di parziali socializzazioni anche solidali, ma la forza di una società contrassegnata dalla sottrazione a ogni vincolo che non sia quello determinato dal potere sociale del capitale.
Su questa scala mondiale giunge al tramonto l’idea di una società pattizia in cui ogni figura della produzione sociale dovrebbe trovare un riconoscimento nei termini di distribuzione del prodotto sociale. Tramonta un’idea di una cittadinanza che chiama diritti le possibilità di accesso alle prestazioni sociali conquistate con le lotte e sancite da accordi e contratti collettivi. Oltre che per la rappresentanza, regna spesso una profonda nostalgia per questa società contrattata. Il sindacato rappresenta il luogo di resistenza più evidente contro la tendenza del capitale a rimuovere il contratto dalla sua posizione di istituzione fondamentale della società. Inevitabilmente il sindacato è anche il più esposto alla nostalgia per le apparenti simmetrie delle regolazioni contrattuali. La società mondiale mette perciò oggi in discussione l’efficacia dell’azione meramente sindacale. La forma sindacale di organizzazione dei conflitti sociali intorno al loro lavoro è infatti catturata in una contraddizione insanabile: mentre è strutturalmente volta alla ricerca di un impossibile reciproco riconoscimento tra lavoratori e capitale, essa è allo stesso tempo l’insieme di pratiche di difesa più diffusa e anche più desiderata di resistenza al predominio del capitale mondiale. E non perché il lavoro stia scomparendo. Il lavoro non sta diventando un’attività sociale residuale come recitavano le retoriche di fine millennio. Le precarie, i migranti, gli operai hanno quanto mai bisogno di forme di organizzazione contro il predominio del capitale globale, ma sempre più difficilmente esse possono mirare a regolazioni giuridiche che ristabiliscano una qualche forma contrattuale dei rapporti sociali. Solo un’organizzazione in grado di destrutturare le frontiere mobili del capitale anticipandone i movimenti sembra essere all’altezza di questa situazione. Le lotte sul salario e sulle forme di reddito non possono essere intese come risarcimento per il mancato riconoscimento di una sorta di diritto sociale all’esistenza, ma come lotta contro il dominio sociale del denaro, che deve essere sempre più dispotico, proprio perché non riesce mai a essere davvero assoluto. La produzione sociale – né quella postfordista né quella più enigmaticamente cognitaria – non porta con sé alcun diritto e tanto meno libera automaticamente tempo per attività autonome sottratte alla coazione della società del capitale.
Anche nella periferica Italia giunge invece a compimento quella società attiva prefigurata una decina di anni fa in documenti sia italiani sia europei. Non si tratta di una società in cui si lavora sempre e nella quale tutto il tempo è indiscriminatamente messo a valore. Essa pretende invece una costante e incondizionata disponibilità al lavoro. Le conseguenze, allora impudentemente negate, si sono però nel frattempo completamente realizzate. Flessibilità e precarietà si sono reciprocamente rafforzate: flessibilità nel lavoro e nei lavori, precarietà per tutto il resto del tempo. L’attuale ristrutturazione normativa del mercato del lavoro sancisce l’avvento definitivo di questa società, stabilendo l’indisponibilità a ogni mediazione sul salario. Le misure previste mirano a gestire il passaggio da un’occupazione all’altra, lasciando il rapporto di salario, in quanto specifico rapporto di potere, alla forza delle parti. È il segno di una società dominata dalla forza di chi può imporre il salario e le sue condizioni. Una non-società in definitiva, caratterizzata dalla programmatica negazione di qualsiasi reciprocità tra le parti che la compongono.
Ci si accorge così, talvolta stupore e talvolta persino con risentimento, che lo sfruttamento intensivo non è riservato agli spazi globali in cerca di sviluppo. Non c’è nessun ritardo nello sfruttamento che debba essere colmato, come non c’è nessun “diritto” a una forma diversa di sfruttamento nei servizi all’impresa o in quelli pubblici rispetto al lavoro di fabbrica o nei servizi alla persona. È piuttosto in atto una violenta sincronizzazione delle velocità di evoluzione della società che non c’entra in alcun modo come uno sviluppo più o meno selettivo delle aree non ancora sviluppate. E lo Stato è solo uno dei fattori che consentono questo processo. Lo sfruttamento intensivo del lavoro operaio in Cina, come in qualsiasi altro spazio globale, non è reso possibile dalla specificità storica delle condizioni ambientali – argomento sempre gravato da un’implicita intonazione razzista – ma dalla loro connessione con il resto del mondo. La sincronizzazione in atto non allinea tutte le parti del globo a un unico stadio di sviluppo, quanto piuttosto a un unico rapporto di capitale. La precarizzazione del lavoro in Europa è la condizione di quello sfruttamento. E viceversa. Pretendendo di essere la misura universale del rapporto tra spazio e tempo, il capitale è quindi contemporaneamente la causa dello sviluppo e dell’impoverimento, della crescita più accentuata e della ristrutturazione più feroce. Da questo punto di vista sarebbe più salutare riconoscersi in quello sfruttamento invece di considerarlo un segno di arretratezza.
La società è la forma storica in cui si è organizzato e dispiegato il rapporto di capitale. Una società nel senso moderno non è sempre esistita. Proprio per questo possiamo seguirne le evoluzioni storiche fino alla sua paradossale forma contemporanea. Accettarne la contingenza significa riconoscere la profonda divisione che la caratterizza ben al di là delle retoriche sulla sua unità e sulle diversità storiche. L’evidenza quotidiana della divisione è la potenziale fine della società: è il segno che non solo è possibile disobbedire e sottrarsi, ma rompere il rapporto sociale che nella sua assenza materiale incatena alla precarietà e allo sfruttamento. Una società senza contratto ha rinunciato a presentarsi come comunità, per mostrarsi come rapporto di potere. Se c’è una differenza certa tra il liberalismo classico e il neoliberalismo è che quest’ultimo non ha il problema della società. Il mercato è letteralmente il rovescio della società. Non si tratta però di restaurare le forme contrattuali e nemmeno la mediazione politica che esse rendevano necessaria. L’esperienza globale di una società che rinuncia a presentarsi come legame sociale è una possibilità che non c’è mai stata prima d’ora. Essa manifesta l’evidenza di una separazione che, senza nostalgie e senza sogni di impossibili ricomposizioni, mostra il suo volto di questione di classe. Non è più possibile alcuna simmetrica contrapposizione di classi omogenee che proprio per questo rendono possibile la società. La mancanza di una omogeneità immediata di condizione tra tutti coloro che lavorano in modo precario per un salario minimo, oppure sono disoccupati e poveri è un problema che non si risolve all’interno di questa società mondiale. Il compito che abbiamo davanti è quello di connettere queste esistenze separate, senza pretendere di rappresentarle come unità indifferenziata. L’esperienza sempre più globale della separazione concede una possibilità di azione collettiva contro le gerarchie che pretendono di legittimarle come fatti naturali della società.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




